[di Letizia Soriano]
Forse la più bella delle colonne
su cui si regge il mondo
poggia al centro dell’atrio di una scuola
sotto la luce ghiacciata dei neon
quando fuori è buio, le aule vuote
ma dietro una porta
qualcuno siede al pianoforte
e per la prima volta, un bambino
avvicina all’incavo del collo
il suo violino.
(da Piccolo canzoniere di Silvia Vecchini, Edizioni Sartoria Utopia 2021)
Scuola per me è una parola collettiva: dentro ci sono alunni, maestri, genitori e anche tutto quello che non si vede, ma che spesso lascia tracce indelebili nell’esperienza di ciascuno. Ogni scuola, un modo di fare; ogni classe, un microcosmo che respira con un ritmo diverso a seconda della composizione, delle abitudini, delle provenienze. Potremmo dire che ogni classe è un’esperienza unica perché unici sono i suoi abitanti. Ogni bambino porta il suo vissuto che insieme a quello dei compagni crea la base su cui poggerà il sapere che negli anni si andrà costruendo. Utilizzo il termine sapere perché credo realmente nella costruzione di un percorso in cui la conoscenza, sia individuale sia collettiva, possa diventare un potente strumento di emancipazione, soprattutto in una società che sta divenendo sempre più digitalizzata e tecnologizzata (e a volte da questo impoverita, anche se dovrebbe essere esattamente il contrario). Un luogo, dunque, dove si ha necessità continua di manutenzione educativa e didattica.


Noi insegnanti, anche se troppo spesso disillusi dal pensiero di poter fare la differenza - dunque senza rendercene conto - possediamo moltissimi strumenti di lavoro a cui possiamo attingere. Sicuramente i primi sono la nostra esperienza e la nostra formazione a cui accediamo per risolvere, rivedere, registrare le varie problematiche che sorgono all’interno del lavoro quotidiano. Ma la formazione basta all’esperienza? E l’esperienza basta alla formazione? Sicuramente quest’ultima spesso si riduce a qualcosa di sporadico e, quando non concerne corsi obbligatori (come quelli sulla sicurezza), viene rinviata quasi solo all’iniziativa personale, alle curiosità coltivate in piccoli gruppi di persone affini. Non esistono percorsi organici di formazione su alcune tematiche a mio avviso fondamentali (come non pensare subito alla letteratura per l’infanzia?) a cui accedere. Quello che c'è si muove in base alla buona volontà e all’estro di pochi. E questo non basta, non può bastare, perché alla lunga la mancanza di formazione può creare in coloro che non vi investono (ma che vantano lunga esperienza) false certezze piuttosto pericolose, tra queste l’illusione di poter replicare gli stessi identici percorsi via via che le generazioni cambiano. Sappiamo benissimo che questo risulta poco funzionale per i motivi cui accennavo sopra: l’unicità che ogni gruppo classe porta e tutti i cambiamenti che arrivano attraverso la società: occorre avere la pazienza e la voglia di stare nel cambiamento insieme ai nostri alunni. Un esempio concreto lo vediamo grazie alle classi sempre più multietniche. Il maestro di Giove, Franco Lorenzoni ripete spesso che «la scuola deve essere migliore della società. Altrimenti a cosa serve?»

In effetti, dentro la scuola riusciamo realmente a sfiorare gli apici delle migliori utopie: la condivisione, l’ascolto, l’accettazione dell’altro, la tolleranza… ma anche l’esatto opposto: la frustrazione, la negazione dell’altro, l’intolleranza, la divisione. Noi insegnanti ci troviamo a navigare in mezzo a questo spartiacque: avvistiamo l’utopia, cerchiamo di raggiungerla con sforzo ed esercizio continuo, riusciamo a sfiorarla, a farle il solletico, ma poi nel tempo di un battito di ciglia, ricadiamo con un tonfo nelle più basse esternazioni umane e ci ritorna quella sensazione di spossatezza e poca fiducia. La formazione, che è sia incontro con l’altro quindi con la società, sia l’incontro con sé stessi, attraverso il tema che si va ad approfondire, aiuta ad avere fiducia che quel filo verso l’utopia possiamo continuare a tenderlo ogni giorno mettendoci del nostro.

Pasolini scrive qualcosa a proposito di queste sfumature. Sono parole che io mi porto dietro e di cui faccio tesoro nei momenti più difficili:
«Il lavoro del maestro è come quello della massaia, bisogna ogni mattina ricominciare da capo: la materia, il concreto sfuggono da tutte le parti, sono un continuo miraggio che dà illusioni di perfezione. Lascio la sera i ragazzi in piena fase di ordine e volontà di sapere - partecipi, infervorati - e li trovo il giorno dopo ricaduti nella freddezza e nell'indifferenza.
Per fare studiare i ragazzi volentieri, entusiasmarli occorre ben altro che adottare un metodo più moderno e intelligente. Si tratta di sfumature, di sfumature rischiose ed emozionanti. Bisogna tener conto in concreto delle contraddizioni, dell'irrazionale e del puro vivente che è in noi. Può educare solo chi sa cosa significa amare».
Questo potrebbe essere un pensiero che fa la differenza nel lavoro quotidiano: tenere conto delle contraddizioni è uno degli esercizi più faticosi e più necessari del lavoro educativo perché ha a che fare con l’integrazione di situazioni apparentemente lontane e differenti che devono, in qualche modo, convivere. È un processo che ha bisogno di tempo. È sia una ricerca personale (e possiamo domandarci quanto, di questa ricerca, riusciamo a portare in classe e in che forma) sia l’espressione materiale delle piccolissime scelte di ogni giorno: le parole che usiamo, il tono della voce, i rapporti che andiamo tessendo, le attività proposte. In sostanza dipende moltissimo da noi.
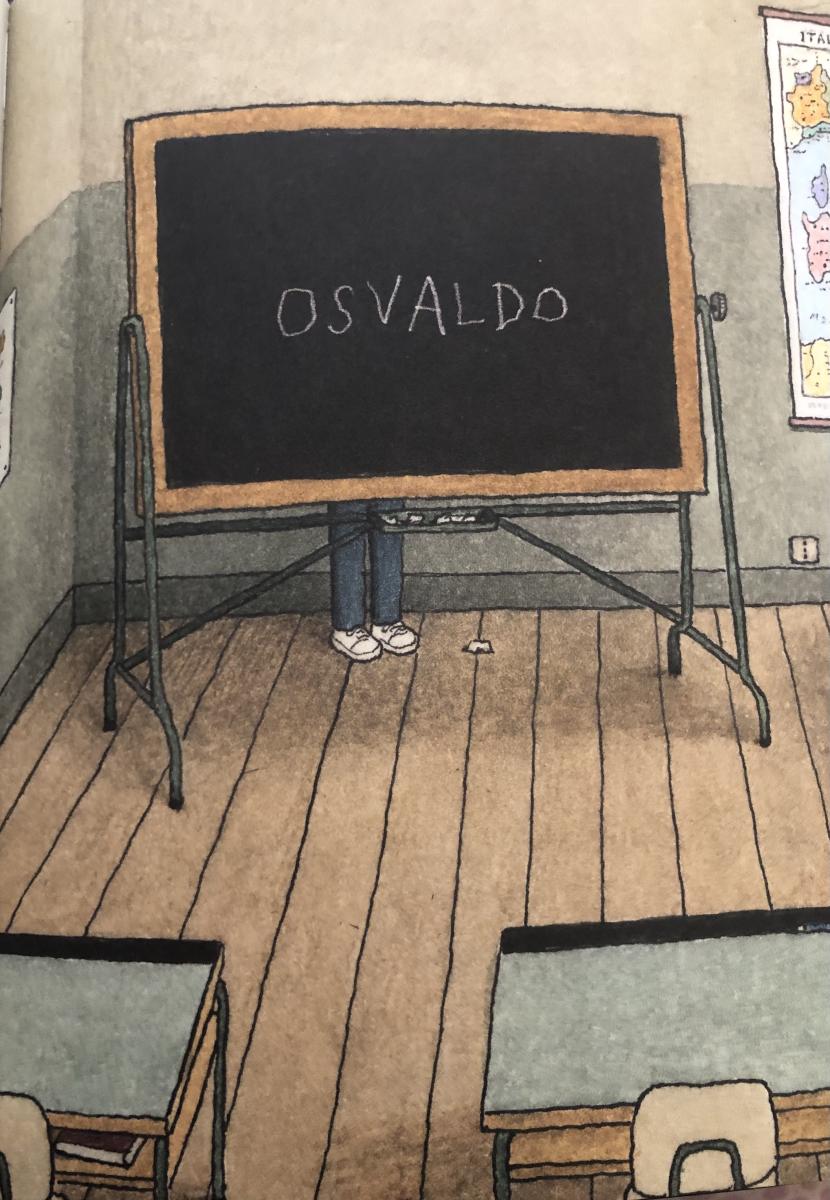
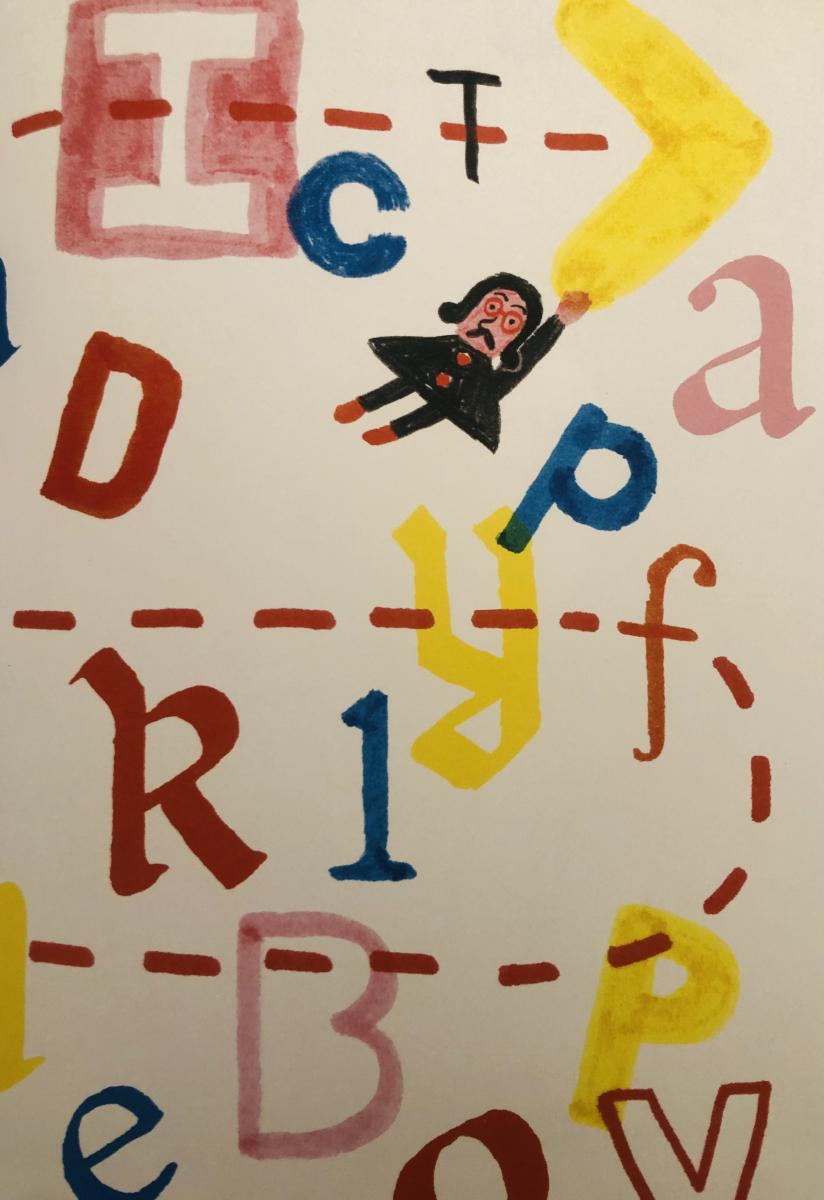
Portavo prima l’esempio della letteratura per l’infanzia, un tema a me carissimo e credo anche a coloro che stanno leggendo: i bambini non potranno mai avvicinarsi alla lettura con curiosità, con sensibilità, con interesse, se a noi per primi, in modo diffuso, mancano certi presupposti: l’ascolto, la lettura, l’approfondimento, la ricerca, lo scambio. Non sentiranno neanche nessuna inclinazione alla scrittura, alla sperimentazione di certi linguaggi, di certi registri, se noi insegnanti non siamo sufficientemente preparati, se non abbiamo gli strumenti giusti per scegliere. Qui si apre il vastissimo tema del rapporto tra lettura e scrittura che meriterebbe uno spazio tutto suo, mi limito a dire che lettura e scrittura - lettura come comprensione di sé e del mondo, scrittura come possibilità/necessità di comunicazione a diversi livelli - sono discipline importantissime, alla base di tutte le altre e per questo hanno bisogno di estrema cura. Spesso nei libri di testo questa cura non esiste. Troviamo brani interamente vivisezionati, esercizi compilativi realmente discutibili, errori e sciatterie. Consultandoli, mi sono interrogata spesso e volentieri.

Io arrivo da una lunga esperienza in una bellissima scuola paritaria (il CEIS di Rimini) dove, da sempre, ci si avvale della scelta alternativa; dunque, ho iniziato a insegnare senza l’utilizzo del libro di testo, ma sfruttando testi di divulgazione di ogni tipo, materiale autoprodotto e piccole, ma fornitissime biblioteche di classe. Un lavoro immane, durato quindici anni, ma altrettanto soddisfacente. Si può facilmente immaginare quanto sia stato complicato il mio ingresso nella scuola pubblica, soprattutto in relazione all’utilizzo dei libri (che a oggi non sono ancora perfettamente in grado di padroneggiare e dove la scelta alternativa è un lontano miraggio). Ricordo bene, la prima volta in cui mi sono ritrovata a sfogliarli con criterio, la sensazione di sbalordimento che ho provato. Ho pensato “ma qui c’è tutto! Pure messo in fila, già pronto, già scritto, e soprattutto già pensato”. Mi sono abbandonata a questa gozzoviglia di spunti con grande sorpresa, ma anche con un po’ di inquietudine. Perché se da un lato capivo che avrei fatto meno fatica, dall’altro vedevo bene che alcuni percorsi già segnalati potevano essere rischiosi o a senso unico.

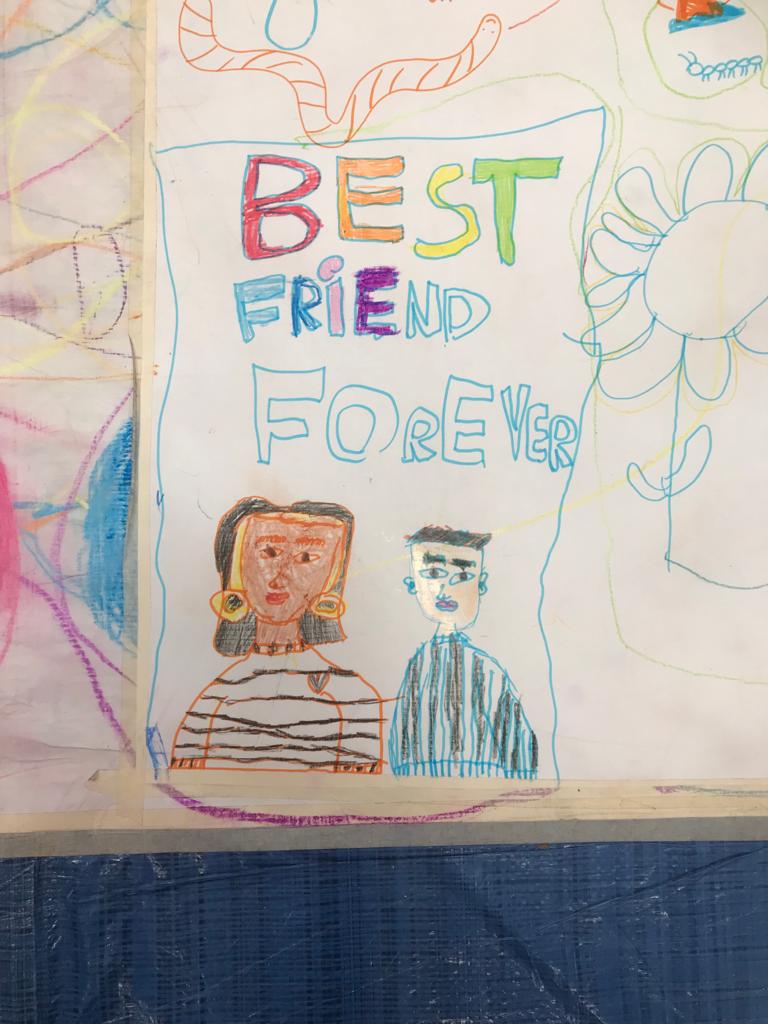
Le domande erano sempre le stesse: sarò capace di mantenere la giusta apertura e la giusta curiosità nei confronti di alcuni temi, utilizzando dei brani che mai avrei scelto?
È giusto evitare la maggior parte dei testi solo perché a me non piacciono, rendendo così il libro inutilizzato? Può un brano mal estrapolato rendere giustizia al testo originale?
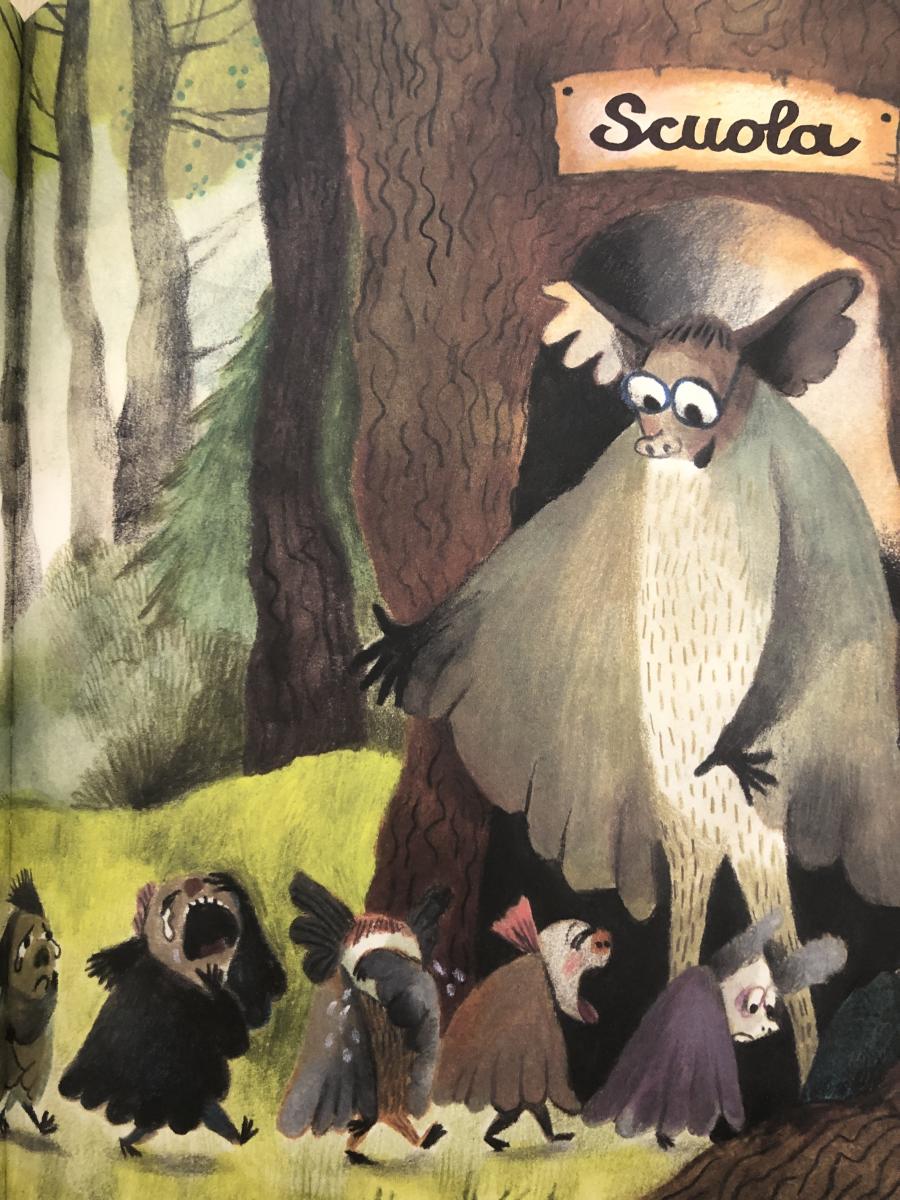
Tutto mi sembrava molto lontano da certe mie convinzioni di base. Dunque, l’operazione più difficile è stata quella di abbandonare mentalmente la struttura del lavoro per come l’avevo sempre portata avanti, cercando ancora qualcosa di nuovo. Per l’ennesima volta ho avuto bisogno di integrare il prima e il dopo in modo il più possibile funzionale, tentando di non snaturare entrambe le esperienze. Non dico che questo non sia stato traumatico, dico solo che con il tempo sono riuscita in qualche modo a superare quel grosso ponte di nostalgia che mi impediva di pensarmi in una situazione nuova, con un limite tutto mio di adattamento. C’è stato poi un altro passaggio importante: quello di portare le stesse domande ai bambini, di non tenerle solo per me. Alla fine di una lettura, estrapolata dal libro di testo, chiedere loro: “Cosa ne pensate? Quali domande avete?” E molto spesso, pur non avendo chissà quale esperienza di lettori, sono riusciti a stanare delle lacune semplicemente attraverso il dialogo. La parte della lettura critica dei testi è, e rimane, uno dei momenti che preferisco. E anche l’idea dell’imprevedibile, di tutto quello che possono trovare dentro un testo che sfugge al mio controllo e alla mia scelta. Questa per me è stata una novità assoluta.

Inoltre, nel cercare di dare voce a tutti i dubbi che ancora adesso mi attanagliano, forse la risposta l’ho trovata pensando alla capacità che hanno i bambini di trasformare ogni esperienza in qualcosa che coinvolge il corpo tutto intero, che va oltre a un’idea puramente razionale e che può diventare anche qualcosa di tattile, di sonoro, di affettivo, di emotivo. A questo proposito mi è tornata in mente, quasi all’improvviso, un’immagine che avevo dimenticato, quella di una pagina di un mio libro delle elementari. C’era, forse, una poesia e poi la foto di una casa abbandonata in mezzo a un prato, un rudere di pietra poggiato su una collinetta all’ora del crepuscolo. L’erba intorno leggermente inclinata per fare posto al vento. Tornavo spesso a guardarla solo per chiudere gli occhi. Aprivo la bocca: il fiato modulava il vento, soffiavo e diventavo vento, lo sentivo passare in mezzo all’erba, tra le crepe della casa abbandonata. In un attimo ero lì, su quel prato incolto, raggiungevo la casa a piedi, cercavo riparo da chissà cosa. Finalmente ero la persona più sola sulla faccia della terra. Quando sentivo i brividi stava già arrivando la notte. Chiudevo il libro.

Grazie a una sola pagina potevo ritrovare quella parte di me che invano aveva cercato un suo spazio nel mondo materiale della casa, di una famiglia tanto rumorosa quanto ingombrante. Il mio posticino era lì e vi ritornavo con estremo piacere, a dispetto di tutto quello che accadeva intorno. Ho cercato per anni quella foto. Correvo a spulciare negli archivi e nelle biblioteche delle scuole quando sapevo che si stava facendo pulizia. Era solo un modo per cercare quel libro, per ritrovare quell’unica immagine, così anonima e così poco importante da non comparire in nessuna ricerca, ma che dentro di me ho continuato a conservare a occhi chiusi, tornando una bambina, finalmente sola, davanti al suo libro di scuola.
