Siamo molto contenti, oggi, di presentare una novità che, dopo Le vite di Ada e prima di Quando il mondo era tutto azzurro, esce nella collana L’età d’oro. Sono le Fiabe incatenate di Beatrice Solinas Donghi, illustrate da Irene Rinaldi (che è riuscita nell’impresa di dotare questi testi bellissimi di un corredo visivo all’altezza), e con una deliziosa nota finale per lettori grandi (ma non preclusa ai piccoli) di Carla Ida Salviati, fine conoscitrice, nonché amica, della scrittrice, mancata nel 2015. Come e perché abbiamo deciso di pubblicare questo libro lo si spiega qui.
[di Giovanna Zoboli]
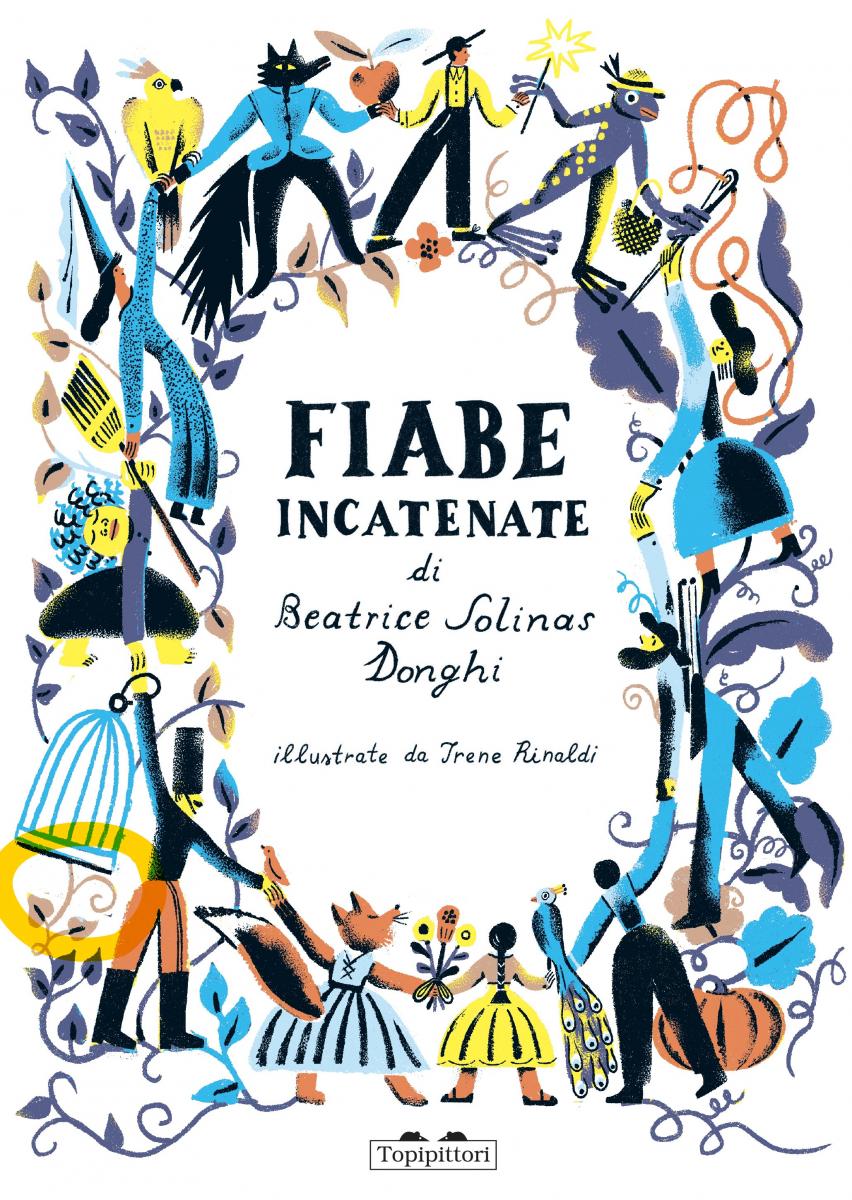
La copertina delle Fiabe incatenate di Beatrice Solinas Donghi, illustrate da Irene Rinaldi.
La prima cosa che ho letto di Beatrice Solinas Donghi è stata Fiaba come racconto (Marsilio, 1976), saggio che la scrittrice ha dedicato alle fiabe di cui è stata attenta e acuta studiosa. Mi piacque molto. Era il 2004 e stavo preparando un corso in cui avrei trattato anche di fiabe. Avevo letto qualcosa a proposito di quel saggio e capii che conoscerlo doveva essere importante. Lo fu, per tanti motivi. In quelle pagine lessi una cosa che poi mi ha accompagnato fino a oggi e che, durante i corsi di scrittura che ho tenuto, non molti a dire la verità, ho sempre sottolineato. Ovvero, se esiste un genere letterario in cui la forma del testo è fondamentale per la buona riuscita della narrazione, è la fiaba, che discende da una abilità di linguaggio raffinatissima, messa a punto nei secoli da migliaia di narratori orali che avevano come mandato quello di tenere desta l’attenzione di un pubblico di cui scorgevano, per avercelo davanti, ogni minimo segnale di disattenzione e noia. La noia: il più severo dei critici, il più implacabile.
Nelle fiabe, infatti, che siano popolari o letterarie, fondamentale è il ritmo, parte essenziale nella costruzione del racconto. Nelle fiabe, che nascono come narrazioni orali e portano l’oralità nel proprio dna, il ritmo coincide con la dizione orale, la cadenza narrativa della viva voce. Il narratore, che si trova sempre nella condizione di percepire lo stato dell’attenzione dei propri ascoltatori, costruisce la trama secondo una orchestrazione ritmica serrata, sapiente, rapida, tesa. Sa che la storia deve essere un meccanismo perfetto, capace di tenere alta la soglia dell'attenzione attraverso una forma perfetta, altrimenti non funziona.

Cito il passo a proposito di questo aspetto, dal saggio di Beatrice Solinas Donghi: «Al narratore orale è precluso il grigiore e l'uso dello sfumato; i mezzi con i quali ottiene la sua meccanica interiore di momenti sospensivi e risolutori debbono potersi mandare facilmente a memoria (che è come si capisce la prima esigenza di ogni narrativa non scritta); essere semplici, perciò, e nello stesso tempo abbastanza brillanti da colpire l'attenzione. Mancandogli le sottigliezze dell'analisi psicologica e le risorse descrittive del naturalismo, capaci di restituire sulla pagina l'immagine di un mondo reale, il narratore orale è condannato, per farsi ascoltare o anche solo per tenere insieme i suoi racconti alla ingegnosità coatta e alla bravura scoperta. Tra parentesi, penso che proprio questa necessità di farsi ascoltare, preceduta e seguita dall'altra necessità non meno urgente di farsi ricordare da chi la narra, spieghi come mai le fiabe della tradizione popolare siano generalmente, nei risultati artistici, molto superiori ai «generi» della letteratura popolare scritta; per esempio il romanzo d'appendice. Il guaio, per simili romanzi, fu proprio d'essere scritti, cioè fissati per sempre così, come venivano messi giù da mestieranti con poco tempo a disposizione, premuti dalla necessità di guadagno. Nella fiaba orale, al contrario di quel che si potrebbe pensare, la faciloneria è molto più rara; si direbbe che in essa gli apporti delle successive generazioni e la cura della «memorabilità» del racconto (cioè, nei risultati, della sua concisione, vivezza e coerenza interna) siano riusciti a sostituire il travaglio dello scrittore coscienzioso.»


A proposito della bellezza formale eclatante della fiaba, si è espresso Italo Calvino, nelle Lezioni americane, al capitolo Rapidità quando spiega la propria predilezione per la fiaba: «Se in un’epoca della mia attività letteraria sono stato attratto dai folktales e dai fairytales, non è stato per fedeltà a una tradizione etnica, né per nostalgia delle letture infantili, ma per interesse stilistico e strutturale, per l’economia, il ritmo, la logica essenziale con cui sono raccontate.» E più avanti: «Come per il poeta in versi così per lo scrittore in prosa, la riuscita sta nella felicità dell’espressione verbale, che in qualche caso potrà realizzarsi per folgorazione improvvisa, ma che di regola vuol dire una paziente ricerca del mot juste, della frase in cui è ogni parola è insostituibile, dell’accostamento di suoni e di concetti più efficace e denso di significato. Sono convinto che scrivere prosa non dovrebbe essere diverso dallo scrivere poesia: in entrambi i casi è ricerca d’un’espressione necessaria, unica, densa, concisa, memorabile.»
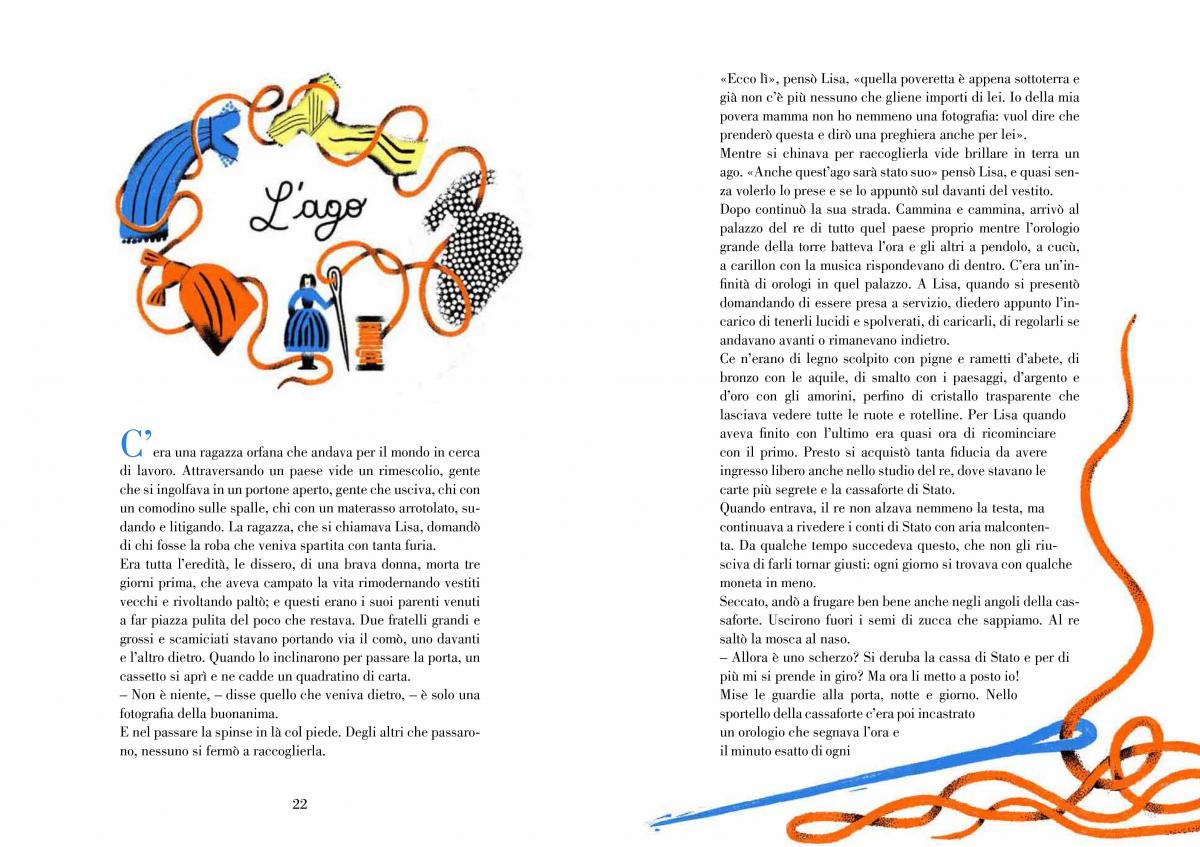

A proposito di questa natura rapida, fulminea che poesia e fiabe condividono, mi viene in mente Chandra Livia Candiani quando, raccontando la scoperta della poesia, da bambina, scrive: «Prima di andare a scuola, attorno ai cinque anni, c’è stata la faccenda di Pascoli. Sempre Max, mio fratello, studiava una poesia a memoria, diceva e ridiceva parole strane, sonore ma che creavano in corridoio delle immagini: rondini, nidi, bambole al petto, cavalline, stelle. Camminando lungo quel brutto e anche un po’ cattivo corridoio, le parole mi colpirono alla schiena, mi immobilizzai e le ricevetti, correvano le immagini un po’ di qua e un po’ di là e io mi dissi solo: “Da grande scriverò in quella lingua.” … In realtà, cercavo la poesia dappertutto, mi stufavo appena uno scrittore si dilungava, mi sentivo abbandonata appena scriveva cose senza sussulto. Cercavo vie di comprensione del mondo e della vita fulminanti. Cercavo la poesia.» (in Vibrisse, La formazione della scrittrice, 10 / Chandra Livia Candiani ).
Non stupisce che Chandra Livia Candiani sia anche autrice di fiabe, oltre che di poesia: benché in modo diverso dalla poesia, la fiaba, attraverso una lingua che stringe in un nodo strettissimo il corpo vivo della parole a quello del mondo, offre vie di comprensione fulminanti delle cose, vie che catalizzano attenzione e memoria.


Tornando a Beatrice Solinas Donghi, dopo la lettura del saggio mi venne la curiosità di leggere le fiabe che aveva scritto, che ancora non avevo letto. Mi chiedevo come se la cavasse, alle prese con la materia narrativa, una studiosa così rigorosa a proposito del concetto di bellezza di un testo. Così mi procurai le sue Fiabe incatenate. Fu una grande sorpresa: erano fiabe magnifiche, prodotto di una mente raffinata, sagace, ironica, colta, geniale. Testi di misura perfetta, legati l'un l'altro da un meccanismo narrativo brillante: ogni fiaba (procedendo al modo delle rime incatenate), racconta le avventure di un personaggio, secondario, incontrato nella fiaba precedente, così da creare una struttura circolare. Mi chiesi il motivo per cui Beatrice Solinas Donghi non fosse famosissima, considerata la qualità della sua scrittura, e questa sua raccolta di fiabe non fosse entrata di diritto nel novero dei classici italiani per bambini e ragazzi. Le vicissitudini della fama e del successo, si sa, sono più capricciose, ingiuste e casuali della più volubile delle mode. Per cui conviene non fidarsi troppo, e accettare che capolavori o anche solo gioielli della letteratura rimangano confinati, purtroppo per la repubblica dei lettori, specialmente quella dei bambini, fra le letture per pochi. O meglio, accettare no, non è possibile: ma farsene una ragione, sì, e, dopo essersela fatta, magari fare in modo che tale destino muti. Ecco, questa nuova edizione delle Fiabe incatenate che abbiamo avuto la possibilità, imprevista, di pubblicare, mira proprio a questo: restituire a questa raccolta il posto che merita nei cuori e nei pensieri dei lettori, grandi e piccoli.



Mi è capitato, alcune volte, in incontri con i bambini, di notare quanti di loro fossero sensibili e attenti alla forma dei testi che leggevo, che fossero miei o di altri: “Come sono scritti bene. Come si fa a scrivere così?”, chiedevano. Mi ha sempre colpita questa domanda. Di solito i bambini sono rapiti dalle immagini che trovano nei libri e, quando hanno occasione di incontrarli, chiedono agli illustratori come fanno a disegnare così bene. La loro abilità nel fare li incanta. Nell’opinione corrente, il linguaggio, invece, è percepito come abilità naturale: se pochi sanno disegnare o suonare, per esempio, tutti sappiamo parlare e scrivere. Questo porta a pensare al linguaggio come a una capacità data, acquisita. L'equivalenza fra parlare e scrivere è molto diffusa. In realtà basta cominciare a scrivere anche solo un curriculum o una comunicazione all’amministratore di condominio per rendersi conto delle difficoltà che pone la parola scritta. Accorgersi che la scrittura, la narrazione è, anche, una tecnica precisa che poco ha a che vedere con il linguaggio quotidiano, denotativo, funzionale alle relazioni correnti, significa avere un'acuta sensibilità. E i bambini ne sono provvisti. Una sensibilità che sa apprezzare la qualità e la nobiltà del linguaggio e riconosce, cosa che mi lascia sorpresa, la letterarietà di una scrittura. Per me la letterarietà è proprio questa caratteristica altra del linguaggio, è il modo in cui la lingua, allontanata dai suoi usi funzionali, diventa strumento per creare, incendiare, illuminare, definire, ordinare, nominare, dar forma. È un'improvvisa chiarezza, un fare luce, per usare un'espressione usata da Wisława Szymborska, a proposito della natura dell'ispirazione.
Mi rende molto contenta questa osservazione dei bambini rispetto alla scrittura che incontrano in un libro, perché per me questa è la lingua che dovrebbe abitare nei libri per i bambini, quella cosa che mentre leggi ti afferra: «Ascolta, fermati, qui c'è qualcosa di nuovo, c'è un modo di dire le cose importante. C'è una lingua come non hai mai sentito e come non sapevi potesse essere. Qui si fa una rivoluzione del pensiero.»


Sempre Calvino, nelle Fiabe italiane, a partire dal loro incipit perfetto, la fiaba di Giovannin senza paura, fornisce un prontuario di estetica, un kit senza pari della strumentazione necessaria allo scrittore, ma anche al lettore, poiché non si dà l’uno senza l’altro. Lezione numero uno: «Ogni operazione di “rinuncia” stilistica, di riduzione all’essenziale è un atto di moralità letteraria», scrive il calvinista Calvino alla fine del secondo paragrafo della lunga introduzione al volume. Lezione numero due: «La funzione morale che il raccontare fiabe ha nell’intenzione popolare, va cercata non nella direzione dei contenuti, ma nell’istituzione stessa della fiaba, nel fatto di raccontarle e di udirle», prosegue. Lezione numero tre: «La tecnica con cui la fiaba è costruita si vale insieme del rispetto di convenzioni e della libertà inventiva», conclude.
Ecco Beatrice Solinas Donghi, che fu ammirata da Calvino come studiosa e come scrittrice, nelle sue Fiabe incantenate esemplifica il concetto di esattezza di stile: un narratore che si mette al servizio del testo e lo ascolta con orecchio sensibile e attento; la parola del narratore che, come un sismografo, registra ogni variazione dell’attenzione di chi ascolta; un orecchio che costruisce il procedere della narrazione sullo scivolosissimo, sottilissimo crinale, fra convenzione e libertà.

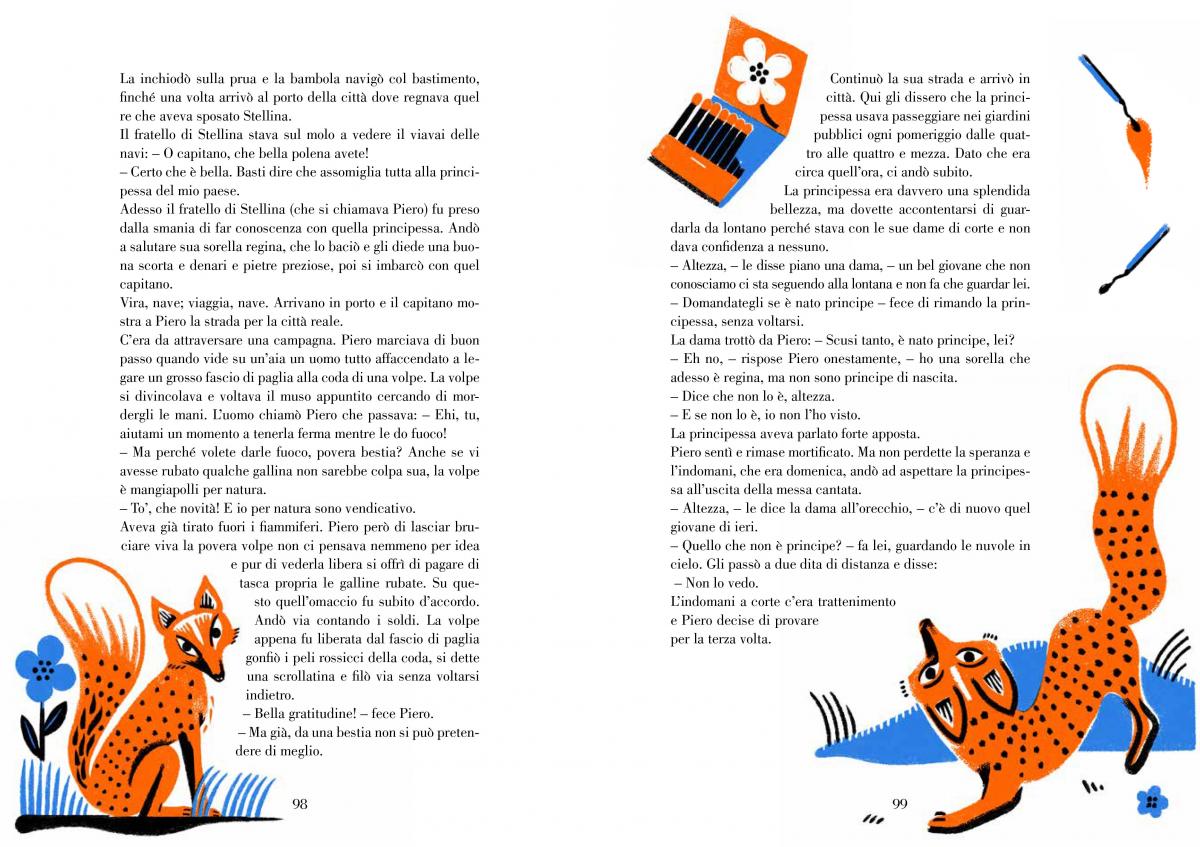
In Troppa famiglia fa male, che al centro del discorso ha il linguaggio e l’apprendimento del linguaggio come parte fondante dell’educazione alle relazioni umane, alla democrazia, alla polis, la psicoanalista Laura Pigozzi scrive: «… la forma, l’andamento, il ritmo di una scrittura, è già pensiero.» Riconoscere la bellezza di un testo letterario, farla sperimentare ai lettori, soprattutto fin da piccoli, è importante. Di più, è fondamentale, perché il suo esercizio, attraverso la lettura e l’ascolto è pratica viva, rivoluzionaria di pensiero. Le fiabe sono grandi, splendide maestre, in questo.

