[di Michele Longo]
Quest’anno, per chi ancora non lo sapesse, ho la prima. Come misura dispensativa, non dovrei leggere niente di argomento scolastico. Ma poi…
Il pezzetto di dibattito sulla scuola che riesco a captare, mi sembra che funzioni così: dall'alto viene lanciata, o lasciata negligentemente cadere, una parola, che, più giù, qui, nelle bolle, sui giornali, scatena un turbine di altre parole, destinato a quietarsi nel giro di pochi giorni. Poi, lo schema si ripete. Lo ammetto subito. I turbini di parole, e forse le parole stesse, soprattutto quando girano intorno alla scuola, mi danno, ultimamente, un senso di fastidio. Io, che insegno ai bambini a leggere e scrivere, che leggo loro infiniti libri pieni di parole stravaganti, che a poco più di un anno sapevo riconoscere e nominare una stamberga, che senza le rime e le assonanze esisterei pochissimo, vorrei che si tornasse, sulla scuola, a parlare di fatti. Fatti, non parole. Lo so: sembro una caricatura del rodariano commendator Mambretti, proprietario di una fabbrica di accessori per cavatappi. O di quel cavaliere, sua pallida reincarnazione.
A guardare più da vicino, forse, il problema, ammesso che un’insofferenza di michelelongo possa esser considerata un problema, è come tendiamo a comportarci con le parole. Le inseguiamo, di corsa e ciecamente, invece di infilzarle e interrogarle. Una per una. Tu, perché sei stata detta? Da dove arrivi? Cosa vuoi? Porti o nascondi qualcosa? Sei piena o vuota? Sei precisa o intercambiabile? Insomma, vorrei che noi di scuola trattassimo le parole da maestri: maestri del sospetto. In fondo, è un trattamento regale; quello che le parole meritano, se davvero crediamo che siano importanti.
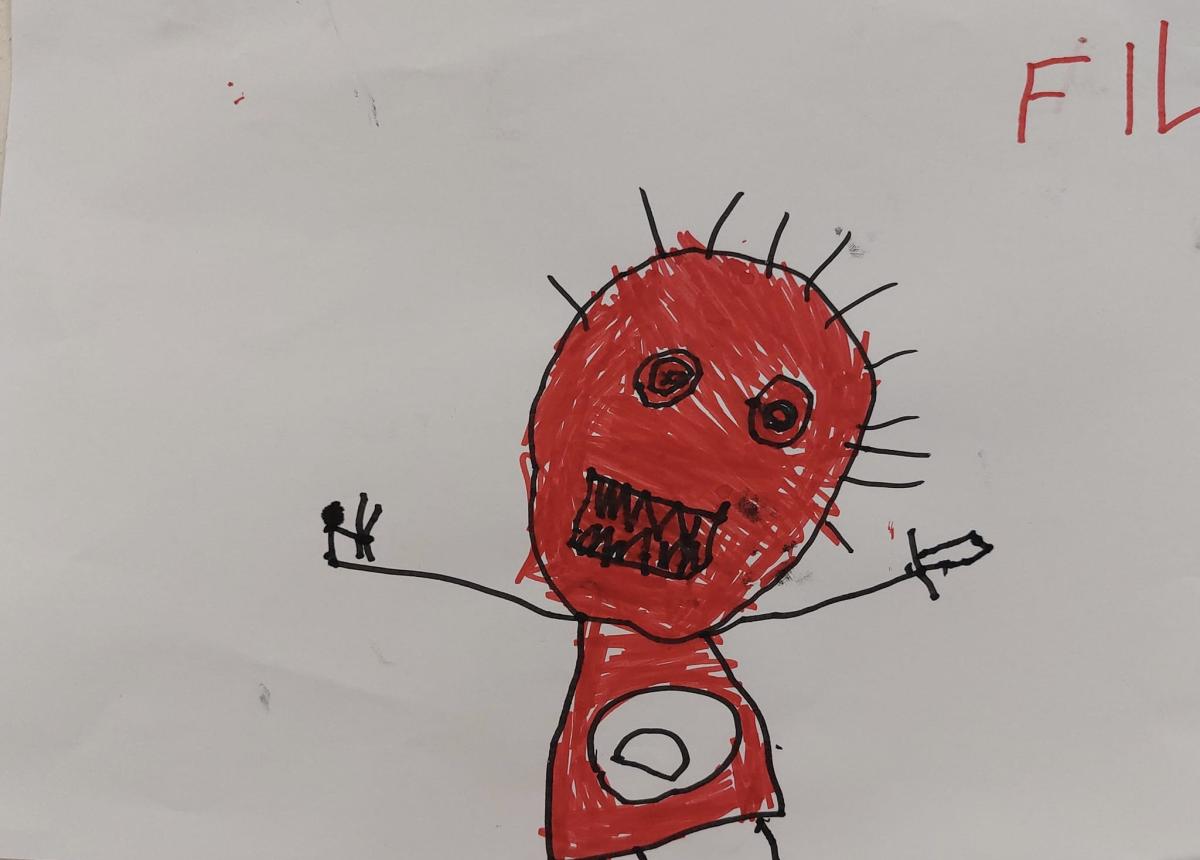

Il primo vantaggio che avremmo, dal metodo del sospetto, o dell’infilza e interroga, sarebbe una bella scrematura: via le parole a brevissima scadenza, le parole d’ordine, quelle del famoso “disco rotto” del mio immaginario vintage, le parole per tutte le stagioni, signoramia. Si interrogano quelle rimaste. Per molte, l’interrogatorio sarà brevissimo: confessano subito. Prendiamo “umiliazione”. Parola da caserma, che accostata alla scuola fa subito “libro e moschetto”, detta per dimostrare di poterla dire. Fine. È terribile? Abbastanza. Ma, come insegna la psicologia transazionale di Eric Berne, portare avanti un botta e risposta di “Non è terribile?” è uno di quei giochi senza creatività e senza uscita, che ci servono per restare al riparo dall’intimità, dall’incontro, dalla ricerca del senso.
Più interessante, nel ricordo, il discorrere del ministro precedente, dotato di una notevole abilità, che a me sembra profondamente pretesca, di dire senza dire, di dire niente per parole e parole e parole, di sfiorare il nonsense e poi infilare, sottobanco, dichiarazioni importantissime: quelle che enunciano intenzioni, provvedimenti, fatti, perfino. Per molte settimane, verso la fine del suo mandato, ha parlato in diversi luoghi e occasioni di “inverno demografico”: formula con un suo fascino distopico d’antan, di quando si credeva che il male venisse dal freddo. Si andava verso gli otto miliardi di esseri umani stipati sulla piccola porzione abitabile del pianeta, e il ministro dell’istruzione - non quello della famiglia o degli affari sociali - affabulava dell’inverno demografico alle porte. Protette dalla loro apparente e quasi svagata assurdità, quelle parole sono passate sopra le nostre teste di maestre e maestre senza entrare nei nostri discorsi, nemmeno in quelli social. Invece, eran parole da acchiappare lesti, infilzare ben bene, e interrogare con tutti i metodi. Perché, appunto, vi ha dette lui, e non il ministro giusto? Non una, ma tante volte? Se non dite, volete. Cosa volete? Se non siete voi, siete i paggi. Di chi? Di che?


Ci avessimo provato, sarebbe stato difficile. Almeno fino all’arrivo del pezzo forte, che recitava, più o meno: “C’è l’inverno demografico, le aule si svuotano, MA a nessuno venga in mente di approfittarne per chiedere la riduzione del numero di alunni per classe. I nostri piani prevedono, anzi, una riduzione progressiva degli insegnanti. Non siamo mica il Bengodi.” A confermare un peculiare tratto pascoliano, l’uomo avrebbe dichiarato di lì a poco che nella scuola elementare le classi poco numerose sono un elemento negativo perché, e qui riporto alla lettera, “I bambini non vi si ritrovano”. Povere pallide creature che si aggirano sperdute tra i pochi compagni, reggendo col braccio teso un fioco lumino. Io e tutte le altre a ridere a crepapelle per il “non vi si ritrovano”, in estasi per il tono di ottocentesca filastrocca didattica: mi, ti, ci, vi, si, ri, tro. E invece, chiuso il racconto d’inverno, ecco un programma a lungo termine di impoverimento della scuola pubblica. Interrogate, le parole del potere, scivolano fuori dal costume di scena, spengono la lanterna magica, e si accasciano sui fatti.
Fatti, dunque. Abbracciata e accompagnata gentilmente alla porta Complessità – che ogni tanto deve fare giretto in corridoio, poi torna - mi azzardo a dire che i maggiori problemi della scuola italiana sono due, parzialmente interconnessi: le classi troppo numerose e il cambiamento continuo del percorso per diventare insegnanti. Le classi numerose costituiscono un elemento di profondo svantaggio per studenti e insegnanti, in tutti i gradi di scuola. Sono le figlie misconosciute di politiche di risparmio sulla scuola pubblica portate avanti da decenni. In modo quasi beffardo, il ministero chiede ai docenti di praticare una didattica sempre più centrata sul singolo studente, “personalizzata”, “individualizzata”, modellata sui “bisogni speciali”, in classi che possono sfiorare i trenta studenti, dove è già tanto mandarli a casa incolumi tutti i giorni. In una classe “piccola” - per la primaria, dagli utopici quindici ai venti bambini - è molto più probabile che in una grande riuscire a stare bene, azzardare spunti di didattica innovativa, costruire una comunità, vedere e dare attenzione a ciascuno, ogni giorno.

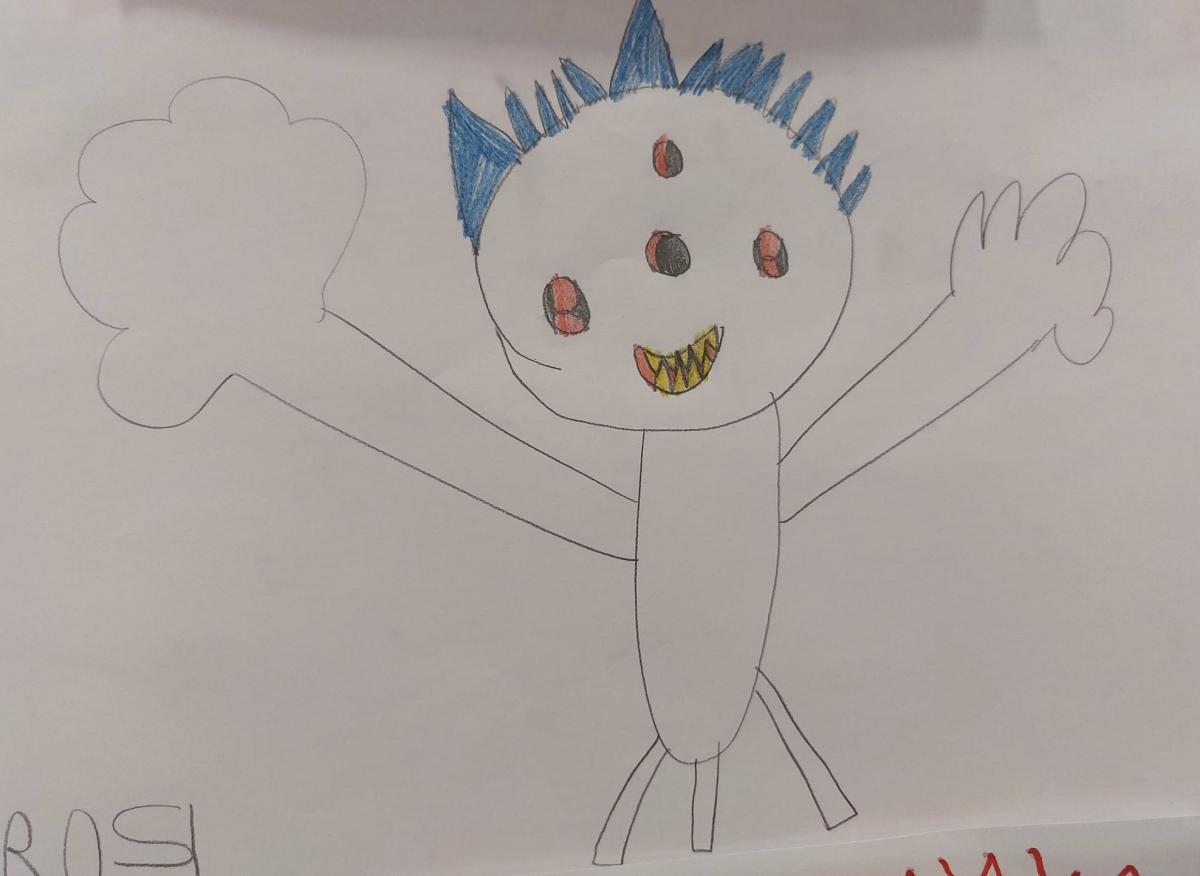
Dicono le statistiche che i docenti italiani sono i più vecchi d’Europa. Non fa meraviglia: nel nostro paese il percorso per accedere alla carriera (se così si può chiamarla) di insegnante è complicatissimo, e cambia in modo capriccioso e insensato con cadenza quasi annuale. Le maestre entrate in ruolo quest’anno, ad esempio, dopo la laurea quinquennale comprensiva di 600 ore di tirocinio, dopo un periodo di lavoro precario da svolgersi al nord per chi abita al sud, ma non viceversa, hanno affrontato un concorso con uno numero di iscritti esorbitante per pochissimi posti, così concepito: una prova preselettiva scritta che richiedeva di conoscere a memoria i programmi ministeriali (peraltro disponibili e facilmente consultabili online nella vita reale), e una prova orale che, da tutti i racconti che ho sentito e letto, è stata condotta con modi quasi intimidatori. Mi dispiace ancora, a pensarci.
Diffido sempre delle massime, attribuite indifferentemente al Dalai Lama o a Petronilla dei Desinaretti, che invitano a “farsene qualcosa dei dispiaceri”. I dispiaceri politici da maestra, però, si possono lasciare lì, e tornare indietro ai fatti. E ai fatti si può dare un morso con il metodo del sospetto, applicato al contrario: punzecchiarli o spremerli per cavarne delle parole. Riportare i fatti, con tutta la loro burbanza realistica, al ruolo di cartomanti, di biscotti della fortuna, di sibille decrepite. Questo il responso che ho avuto sul concorso per la scuola primaria 2022: “Giovani che vi azzardate a voler fare gli insegnanti, abbiate chiaro fin da subito come le cose funzionano e devono continuare a funzionare. Non fatevi venire troppe idee, e, soprattutto, non create precedenti.”
I magnifici mostri che illustrano questo articolo nascono dall'invito a immaginare e disegnare mostri dopo la lettura del libro illustrato Che succede al mostro peloso di Henriette Bichonnier e Paf.
