Oggi, come da qualche tempo accade ogni martedì, gli Anni in tasca festeggiano 10 anni di vita. Lo fanno con un omaggio a un grande studioso di letteratura per l'infanzia, Antonio Faeti. Abbiamo scelto, dal suo L'estate del Lianto, l'intero capitolo La strega del sapone. È un lungo brano, ma ve lo proponiamo integralmente perché in esso c'è tutto il pensiero dello studioso, i suoi temi, il suo sconfinato immaginario, le sue vastissime letture, la sua capacità di tessere nessi, di scorgere parentele, affinità, fra oggetti culturali solo apparentemente lontani e discordi, rivelando il tessuto stesso di cui è fatta quel che chiamiamo cultura. Avere in catalogo questo romanzo bellissimo che racconta l'immaginosa infanzia di uno studioso che all'infanzia ha dedicato tutta la propria vita, è stato ed è un grande onore. Insomma, davanti al professor Faeti, togliersi tutti il cappello.
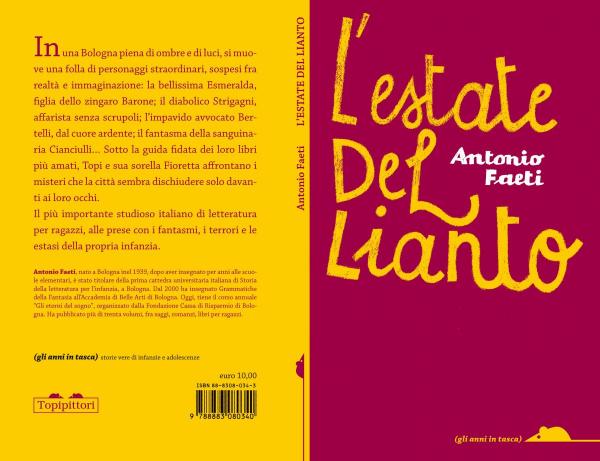
Ho fatto il maestro per sedici anni, ho parlato con tanti bambini, ho ricevuto confidenze incredibili, so bene che l’infanzia ha un suo mondo, pieno di eventi, di segreti, di misteri, e so quanto bisogna temere i malintesi, le informazioni sbagliate, le allusioni incerte.
Ero un bambino, di nove anni, avevo un compagno inseparabile: mio fratello Benito, grande, agile, sportivo, molto bello. Con lui giravo per tutta Bologna, la Bologna del dopoguerra, con tante case distrutte, con molte strade nelle quali si aprivano immense ferite provocate dai recenti bombardamenti. Non era una città sicura, c’era la banda Casaroli composta di sciagurati che erano peggiori di quelli che si vedevano nei film western, c’erano strani tipi ritornati dalla guerra con l’aria di chi non sa bene dove si trova, c’erano bande di ragazzi che avevano perduto i genitori nei tanti disastri accaduti nel corso di ben cinque anni: insomma, un bambino di nove anni avrebbe dovuto restare quasi solo a casa o a scuola.
Ma con mio fratello non avevo paura di nulla: eccoci tra le rovine del vecchio Ospedale Maggiore, crollato dopo il bombardamento e immenso rifugio per i farabutti venuti da chissà dove, eccoci nelle strade senza nome della periferia, dove strane donne e strani uomini si aggiravano come fantasmi, eccoci ai Giardini Margherita, con le baracche dei soldati americani, rimaste vuote e ottimo rifugio per chi voleva nascondersi o combinare traffici proibiti. Io guardavo, stupito, sorpreso, vagamente incuriosito, ma senza alcun timore: ero con mio fratello, non poteva capitarmi nulla, c’era lui a farmi da scudo, con quel suo sorriso eternamente sprezzante e quei grandi occhi azzurri che diventavano grigio-ferro quando si arrabbiava.
Eppure fu proprio Benito a mettermi addosso una paura misteriosa, incancellabile, silenziosa, vergognosa, che non se ne andava mai e restava chiusa in me come un segreto inconfessabile, composto di vergogna, di sospetto, di frammenti di sogno, di incubi impossibili da rivelare.
Eravamo in via de’ Chiari, una piccola, antica, silenziosa strada del centro, quasi priva di negozi, con un suo indubbio fascino medioevale e il senso misterioso di un segreto sussurrato, perché, per metà della sua lunghezza, la strada era fatta di un unico, altissimo muro che racchiudeva il carcere di San Giovanni in Monte. La percorrevo con strane sensazioni, quella strada, perché dietro quel muro pensavo che ci fossero, tutti insieme incatenati, il forzato Jean Valjean, il Conte di Montecristo, l’abate Faria, Rocambole, la Maschera di Ferro e il Fantasma dell’Opera. Il carcere era un antico monastero, c’erano nerissime finestre con tre o quattro inferriate sovrapposte, lugubri, nere, piene di ragnatele: davano sofferenza solo a vederle, quelle finestre, e si pensava ai patimenti di chi stava lì dentro, a carcerieri crudeli, a violenze inaudite.
Io mi ero come incantato a osservare un portone, sotto il portico, che dava su un lungo corridoio e poi su un cortile e infine su un giardino, un autentico “giardino segreto”, dei tanti che mi affascinavano a Bologna, io che venivo dalla campagna e conoscevo solo vigneti, campi di grano, prati di erba medica. Così mio fratello mi chiamò varie volte e infine urlò: «Piantala, vieni via, andiamo, dai… lì ci abita la Cianciulli…»
Raggiunsi Benito e, chissà perché, non gli domandai chi fosse la creatura che portava quel nome e perché fosse così terribile; poi incontrammo i suoi amici, ai Giardini Minghetti, dove, tra scherzi, barzellette, racconti sciagurati, quel nome fu dimenticato insieme con i chiarimenti necessari per decifrare quel senso di misteriosa paura che, una volta tanto, mio fratello mi aveva comunicato.
E non so proprio dire che cosa mi spinse a chiedere informazioni proprio a quel tipo indefinibile, al barbiere apparso nei giorni della Liberazione, venuto dal nulla, vestito con abiti ricavati da due divise, una tedesca e una americana, a quello sconosciuto che aveva aperto una bottega di barbiere subito dopo la porta di casa mia. Sembrava, soprattutto, un pirata malese, uno di quelli che vedevo nelle illustrazioni dei libri di Salgari che avevo già letto. Con i capelli nerissimi e unti, con un intenso colore verdastro nella carnagione, con i grandi denti bianchissimi, a me ricordava l’Oriente delle avventure. Ma si faceva chiamare Fritz e sosteneva di aver lavorato sempre in Germania, abitava nello sgabuzzino, dietro il negozio.
Fu proprio al pirata malese che andai a chiedere, stranamente, chi fosse la Cianciulli.
«Ah… ma certo…» mi rispose «…la Cianciulli… la Saponificatrice… Certo, quella che ammazza le donne per fare il sapone… Stai alla larga, eh? Perché se no diventi una saponetta anche te…»
Trovai, non so come, la forza per proporre un’altra domanda: «Ma…perché non la mettono dentro… perché sta lì, in via de’ Chiari… perché non l’arrestano?…»
«Ah… Sta in via de’ Chiari? Ah, sta lì: alla larga ti ho detto, quella ti trasforma in schiuma da barba, come questa qui…» e mostrava un orrendo pentolino nel quale agitava un miscuglio, verde quasi come lui.
All’inizio dell’Isola del tesoro il povero Jim, quando va a letto, sogna marinai senza una gamba, pirati che si ubriacano di rum, capitani di lungo corso, navi nei mari in burrasca… Beato lui, mi dicevo, perché io venivo visitato, nel sonno, da una sorridente signora grassa che mescolava un orrendo pentolone dal quale si vedevano sporgere mani, piedi, braccia… Io ne sapevo qualcosa, purtroppo, di membra spezzate: avevo assistito, da vicino, ad alcuni terribili bombardamenti, avevo visto corpi ridotti così davvero. Certo: a Savigno, dalla nonna, dove ero stato “sfollato” negli anni di guerra, alcuni aerei americani avevano lanciato spezzoni incendiari proprio sopra la piazza, in un giorno tranquillo, pieno di sole. Si erano viste alcune teste staccate dal corpo che rotolavano verso la chiesa e verso il negozio del fornaio, si era vista una bottega prendere fuoco con un’unica fiammata.
Ecco perché tacevo: avevo l’impressione che la Cianciulli, in quel mondo straziato e capovolto, fosse da considerarsi normale, una donna non più colpevole dei tanti assassini, con varie divise, entrati per sempre nella mia memoria. In un giorno di prima estate osai tornare in via de’ Chiari, da solo, sfidando il rischio di finire dentro il pentolone, ma c’era un sole così limpido, i tigli inviavano ovunque il loro raffinato profumo, io pensavo che un giorno così non fosse adatto per fare il sapone. Così, giunto davanti all’orrendo portone, entrai, percorsi il corridoio, rividi il giardino, dopo il cortile.
Sono passati tantissimi anni, però mentalmente ritrovo, intatta, la sensazione che si impadronì di me nel corso di quella esplorazione. Perché i tre spazi erano del tutto normali, assolutamente identici a tanti altri che si trovavano negli ingressi delle antiche case di Bologna, ma dalle luci, dalle ombre, dai pavimenti che il muschio aveva reso verdastri, dai vasi di gerani un poco rinsecchiti, scaturiva come un senso di abiezione: erano cose normali, però malvagie, insidiose, perfidamente avvolte nel loro mistero. Poi, in fondo al percorso, c’era lei, la Cianciulli, identica all’immagine mentale che avevo di lei.
La strega era grassa, piccola, untuosa, vestita di nero, con un fazzoletto nero che le avvolgeva i capelli e stava lì, con un sorriso falsamente invitante, a guardarmi come se mi stesse aspettando. Era collocata in mezzo a due palme, quelle palme tipiche di tanti giardini interni bolognesi, palme che soffrono, stentano, patiscono per i grandi freddi invernali, ma resistono e sono sempre un po’ grigie, un po’ malaticce. Aveva davanti a sé un pentolone tutto nero di fuliggine, il pentolone della strega, quello che usava per trasformare in sapone le persone che uccideva. Mi voltai subito e corsi via, raggiunsi la mia casa di via Orfeo, non molto lontano da via de’ Chiari, e continuai a tacere, anche adesso che sapevo davvero, adesso che avevo scoperto tutto.
La paura non mi lasciava mai, tanto che mi capitò di vivere un’esperienza sconcertante. Avevo una grande passione per i film di Gianni e Pinotto, due comici diversi da tutti gli altri comici perché facevano sognare, non solo ridere. Entrai nella sala buia del cinema “Carducci”, mentre il film era già cominciato, come usava allora. Avevo riso anche guardando i manifesti e le locandine, e mi faceva ridere anche il titolo del film: Gianni e Pinotto. Avventure a Zanzibar. Mi ero appena seduto quando vidi questa scena: un piazzale assolato di un villaggio, due palme rinsecchite, un enorme pentolone, tante ossa umane e tanti teschi. Corsi fuori, tornai a casa, mi buttai sul letto della mia camerina.
Ma io, della Cianciulli e del suo vivere e operare a Bologna, non volevo parlare con nessuno. Solo con Sergio, il partigiano “Fulmine”, mi azzardai un giorno, prendendola molto alla larga, a raccogliere alcune informazioni che potevano servirmi: «Sergio, Bologna è una città crudele?»
«In che senso?»
«Come al cinema, ho visto Chicago città crudele, ho visto Notti cattive, ho visto La città del vizio… ecco: in questo modo…»
« Penso» rispondeva Sergio soppesando le parole, «penso che a molti Bologna possa sembrare pacioccona, tranquilla, sonnolenta, bonacciona, con i suoi tortellini, la mortadella, il buon vino delle nostre colline…»
« Ma è poi così?»
«No, è solo apparenza: qui la Resistenza è stata durissima, con morti, torture, sparizioni, vendette…»
« Ci sono mai stati mostri, a Bologna?»
« Mostri come? Quelli di Ulisse Aldrovandi? »
« No, quelli che ammazzavano i bambini…»
« Ah… sì, ricordo, più o meno trenta anni fa ci fu un certo Golinelli, fu messo in galera con l’accusa di aver ucciso alcune bambine… ma non ricordo bene… Nel Settecento è esistito una specie di orco che abitava in via San Felice, la strada dove sei nato tu…»
Ecco: il cerchio si chiudeva, la maledizione me la portavo dietro da sempre, fin dalla strada in cui ero nato. E poi la Cianciulli mi aveva ben visto, forse aveva degli informatori, forse era già sulle mie tracce. Continuavo a tacere, concedendomi delle sortite nel territorio degli orrori. La drogheria all’angolo era insolitamente grande, in quei tempi in cui i negozi erano spesso bottegucce oscure, un po’ sotto il livello della strada. Il proprietario, Giorgione, era ambizioso e pieno di idee. Quel giorno aveva riempito una vetrina con una gran quantità di saponette “Panigal” di colore verdino, e la guardava compiaciuto la sua vetrina, mentre si accingeva a collocare il solito cartello che metteva dappertutto, sull’olio, sul vino, sulle cioccolate, scritto con quei caratteri tremolanti di chi a scuola non ci andava volentieri: «Qui tutto a meno».
Così ne approfittai per assumere un po’ di informazioni che potevano risultarmi utili: « Giorgione, come si fabbricano le saponette?»
« Le saponette? Con i bambini. Si prendono due o tre bambini, più o meno come te, si tagliano a pezzi, con cura, per non perdere il grasso, che è la parte più importante, i pezzi vanno messi a cuocere in un pentolone con un fuoco né grosso né piccolo, quando c’è un bell’umidino si aggiunge la soda caustica, poi il profumo, si lascia raffreddare negli stampini, che danno questa forma ovale… È come fare le uova di Pasqua… Lì in quella vetrina, ci sono i bambini di Casalecchio di Reno, quelli scomparsi un mese fa… Vuoi sentire che buon profumino?»
Le mie continue paure mi avrebbero costretto perfino ad accogliere le folli considerazioni di un droghiere noto per le sue bizzarrie e per le sue stranezze. Ad ogni modo, fino a che le saponette furono sostituite da una montagna di scatolette di tonno, con la scritta «Qui tutto a meno», non passai più da quel lato del portico.
Imparai a vivere con lo spettro della Cianciulli, mi vietai di passare per via de’ Chiari, ebbi altri timori, vidi altri spettacoli, cercai di affrontare la scuola media con l’impegno che era indispensabile. Con il babbo leggevo “Epoca” la rivista più nuova e diversa, in quegli anni, sempre piena di servizi complessi, interessanti, approfonditi.
E un giorno vidi un titolo che, forse, cercavo da anni: «Parla Leonarda Cianciulli. La saponificatrice di Correggio intervistata dal nostro inviato nel manicomio criminale di Pozzuoli». C’era anche lei, una donnetta grassa, con due occhialini sul naso, un lucido grembiule e l’aria della vecchia maestra in pensione.
Quello che lessi nelle pagine di “Epoca” era truce davvero, forse perfino più orrendo delle storie che io mi ero tante volte raccontato. Era davvero una incredibile assassina, che aveva ucciso e poi fatto a pezzi tre sue vicine. Le aveva scelte con cura, badando bene che non avessero parenti, era vera anche la storia del pentolone, che stava in solaio. La Cianciulli aveva un suo commercio di abiti usati, con cui viveva bene, e quando veniva interrogata, dopo la sparizione di donne che la frequentavano, mostrava gonne, maglie, cappotto asserendo che la vittima glieli aveva venduti perché decisa a partire per sempre. Rivendeva poi i vestiti, tranquillamente. Sottraeva anche anelli, collane, gioielli che chiudeva entro un mattone.
Aveva strane paure, folli maniacali atteggiamenti, proprio da strega.
Per anni le erano nati numerosi bambini, che presto erano morti, via via, uno dopo l’altro, e queste continue sofferenze l’avevano trasformata, pensava al malocchio, alle magie, alle sventure procurate da chi la odiava. Dopo i processi era sembrato indispensabile non chiuderla in un carcere, ma collocarla in un manicomio criminale, quello di Pozzuoli, appunto. Ma a scoprirla, a trovare le prove, a fare davvero indagini non erano stati i carabinieri e la polizia, ma tre anziane signore di sessant’anni: Albertina Fanti, Lucia Corradi, Ida Codeluppi. Le tre concittadine, di Correggio anche loro, avevano raccolto indizi, seguito tracce, interrogato testimoni: senza la loro ostinazione, il loro coraggio, la loro intelligenza, la “saponificatrice” non sarebbe mai stata individuata e processata.
C’era molta stranezza anche nel terzetto delle donne investigatrici: quello di Leonarda Cianciulli, per me, lettore appassionato di gialli, era un caso molto strano, che andava oltre i gialli, caso che mi fece molto riflettere e che fu all’origine di certi miei studi e di certi miei libri che vennero poi. Perché c’erano le fiabe, i gialli, i western, le storie del mistero, ma poi, soprattutto, c’era la vita vera, più torbida e più complessa delle narrazioni, più sorprendente e crudele delle fiabe crudeli.
E passarono gli anni, diventai maestro di ruolo, mi inscrissi all’università, continuai a considerare Benito, mio fratello, come il mio migliore amico. E avevamo anche una cerimonia, tutta nostra, una specie di patto segreto che rinnovava, di tanto in tanto, quel nostro rapporto speciale. Benito era diventato il brillante ispettore alle vendite di una grande casa internazionale per la produzione di quelle sue tipiche saponette verdi, le “saponette Palmolive”, e di molte altre cose necessarie per lavaggi, igiene, bucati, pulizie varie. Guadagnava bene, doveva correre da un capo all’altro dell’Italia, cambiava spessissimo le sue automobili, ma restava sempre fedele a una sola marca, la “Lancia”. Anzi, da un certo anno in poi, quando usciva un nuovo modello del prestigioso marchio italiano, i concessionari lo mandavano a chiamare e quasi mai lui resisteva alla tentazione. Allora mi veniva a prendere, per mostrarmi il suo nuovo gioiello, e mi portava via con sé, avendo per meta un ottimo ristorante da lui scoperto, dove mi offriva il pranzo o la cena. A metà ottobre del 1970 ebbi la consueta telefonata, vidi la nuova “Lancia”, stupenda, grigio perla, e poi partimmo, per cenare in un ristorante nei pressi di Piacenza.
Era davvero felice, scherzava, cantava, raccontava episodi accaduti nei tanti alberghi dove pernottava nel corso del suo continuo viaggiare per vendere le saponette verdi. Si fermò, prima di arrivare al ristorante dove aveva prenotato, nella grande aia di un podere dove si era fatto degli amici. Tra scherzi e strette di mano, un contadino tirò su dal pozzo dove l’aveva messa a raffreddare, una meravigliosa bottiglia di malvasia che, da sola, valeva il viaggio. Ce la scolammo noi due, bevendo a collo, senza bicchieri, e poi proseguimmo diretti al ristorante. Con quel che bevemmo, anche lì, è evidente che, allora, i controlli sul tasso alcolico degli automobilisti dovevano essere rari o inesistenti.
Era un ottobre dolcissimo, cenavamo all’aperto: culatello, tortelli alle erbe, anatra in umido, torta di ricotta, ancora tanta malvasia. Dalla terrazza dove ci avevano sistemati, si vedeva un’antica abbazia, un pezzo misterioso di medioevo che contrastava con la fulgida “Lancia”, nuova e parcheggiata bene in vista.
Così senza preavviso, interrompendo a metà un discorso, Benito a un tratto mi disse: «Hai visto, sui giornali, che ieri è morta la Cianciulli?»
Non sapevo nulla di questo avvenimento, cosa strana, perché acquistavo ogni giorno quattro quotidiani. Fu solo nei giorni seguenti che potei raccogliere informazioni: era morta in solitudine, era stata tumulata in una fossa comune del cimitero di Pozzuoli, dimenticata, quasi buttata via. Una fossa comune dopo la pentola del sapone, la solitaria sparizione dopo i delitti… Mio fratello ad un tratto disse: «Non siamo molto distanti da Correggio, vuoi che ti porti a vedere i luoghi della Cianciulli?»
Dissi di sì, partimmo, arrivammo, parcheggiammo, osservammo. La casa appariva insidiosa e normale, tranquilla e feroce, aveva la stessa fisionomia che hanno le case in tanti quadri del pittore Maurice Utrillo: un intonaco bianco, le persiane grigie, l’insegna sbilenca di un negozio, due serrande, un platano mal messo, tre comignoli… tutto normale, ma anche troppo vuoto, troppo solitario, troppo silenzioso, un’atmosfera da delitto, chissà, dietro quelle finestre chiuse.
A letto, prigioniero della tipica insonnia che deriva dall’eccesso di malvasia ebbi una di quelle rivelazioni che scaturiscono solo da un certo tipo di bevute. Da quella notte senza sonno sono trascorsi quasi quarant’anni, mio fratello Benito è già morto da quattro anni, io rammento quello che compresi in quella notte di metà ottobre.
In via de’ Chiari mio fratello mi aveva fatto un grande regalo e su di esso avevo sempre taciuto. Mettendomi in contatto, per mezzo di una bugia, con la strega del sapone, mi aveva donato le sirene, le melusine, le morgane, le fate anguane, le sibille, le lamie, le babe-jaghe, le incantatrici, le impietratrici, le maghe, le donne-serpente…
Ho studiato le fiabe, i libri per i bambini, i fumetti, le illustrazioni, le narrazioni avventurose, perché ho pensato, per anni e anni, di camminare sotto gli stessi portici percorsi dalla strega del sapone. Volevo capire, ho imparato a decifrare, ho letto, ho fatto confronti, sempre pensando alle palme, al pentolone, al giardino, e a lei, la vecchia maestra del delitto, nata da una bugia.

