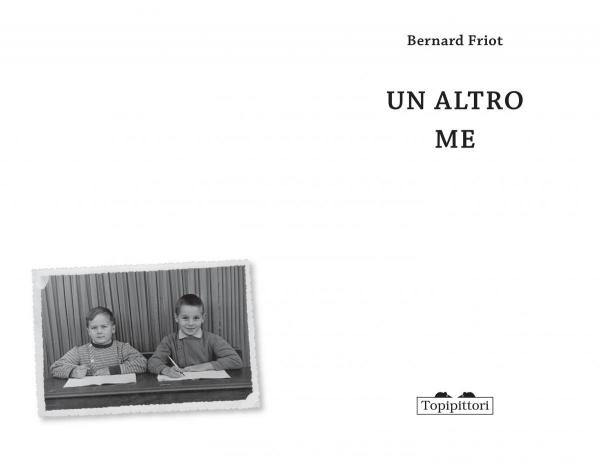Questo martedì l'anno in tasca con cui festeggiamo i dieci anni della collana è Un altro me, splendido racconto sull'adolescenza, ricognizione su una sofferenza interiore resa con una onestà, una precisione, una verità rare da uno dei maggiori scrittori francesi per ragazzi, ovvero Bernard Friot. Vi lasciamo alla sua lettura. La traduzione è di Giovanna Zoboli.
DOMENICA. Tempo grigio a nord della Loira. Foschie e nebbie nelle valli.
Comincia verso le tre. Il pranzo della domenica è finito da poco. C’è stato il solito episodio dei piatti. «A chi tocca?» «A me no! Ho già apparecchiato.» «E perché a lui non tocca mai? Non lo fa neanche durante la settimana…»
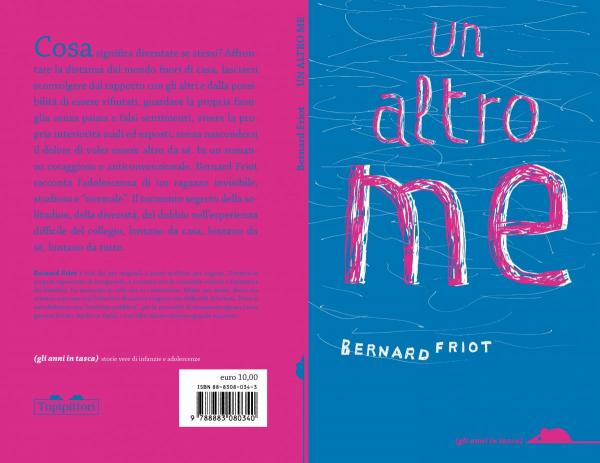
Lui, sono io. E il turno dei piatti non mi tocca durante la settimana semplicemente perché non ci sono, sono via. Frequento il liceo come interno in un convitto, a ottanta chilometri da qui, dall’altra parte di Parigi.
Posso anche farli, i piatti, se insistono. Tanto è come se già fossi via. Sono arrivato ieri, verso le sei, e tra poco riparto. Me ne vado ancora prima che se ne accorgano. Non partecipo nemmeno più a queste discussioni che solo l’anno scorso erano parte della mia vita. Sono qui provvisoriamente, e li guardo da lontano. Nella mia testa, mi sono già chiuso la porta alle spalle.
Faccio un po’ d’ordine in camera mia. O meglio, nella mia vecchia camera: ci sto così poco ormai, che di me non c’è quasi più traccia. Mio fratello Eric ha invaso tutto, attaccato alle pareti i poster coi piloti di formula uno, seminato sul letto e la moquette i suoi vestiti e le sue riviste.
Ora sono solo. I miei fratelli sono già usciti, uno dopo l’altro. Mio padre non so dov’è. Mia madre è in soggiorno a stirarmi la camicia.
Ed ecco, comincia. Mal di pancia. Non proprio male. Solo una sensazione di vuoto, una mano, dentro, che mi stringe lo stomaco. In questi momenti ho freddo. Parto fra un’ora. Un’ora persa, ingoiata da questa paura vaga. Angoscia.
La valigia non è ancora chiusa. Ci ho messo la camicia stirata e il sacco di tela per la biancheria sporca della settimana. Come su tutti i miei vestiti e sui miei oggetti personali sopra ci sono un numero e una lettera: 92A. Là non sono che un numero.
Faccio scattare le serrature, a sinistra e a destra. La valigia non è grande né troppo pesante. Una valigia a buon mercato, in Skai, con una tasca esterna. Ci sistemo anche il panino che mi ha preparato mia madre (prosciutto, tre fette di pomodoro, una foglia di insalata). Non lo mangerò, ma è indispensabile, credo, al rito della partenza.
Parto ancora prima di partire. Prendo le distanze da loro. Che restano al caldo, alla luce, e mi respingono. Ce l’ho con loro ma non lo dico, taccio. Incomprensibile, come al solito, nello spazio segreto che mi sono costruito. Invisibile, ma non lo sanno, perché non mi guardano.
Li amo, certo, senza dubbio, ma è un’evidenza, una necessità. Sarebbe un inferno non amarli. Li amo per precauzione, per errore. Perché si ha bisogno di amare, ci sono slanci incontrollati che mettono in pericolo fuori dalla propria zona di sicurezza. Quando uno ama, si espone, mette a nudo una parte di se stesso, ed è proprio lì che possono ferirti. Ferire a vita, ferire a morte.
Amare i genitori e i fratelli è un rischio minimo. È un amore così banale che non sconvolge, non impegna.
Amo questo genere di pensieri, mi ci diverto segretamente. E me ne vergogno. Sono un ingrato, un egoista. È male. Me li lascio girare in testa, sono armi contro un male più assoluto: non essere riamato, amare e non essere amato. So bene che se mi lasciassi andare, se non reprimessi il mio cuore fino a soffocarlo, amerei alla follia, brucerei d’amore. A volte mi capita, nei momenti in cui l’emozione è d’obbligo, Natale o la festa della mamma, e scrivo poesie ridicole, grondanti di amore inutile.
È sempre più raro. Mi controllo, ora. E ho tutto questo odio che mi protegge da me stesso. Perché mi lasciano andare via? Perché mi mandano in quel liceo? Non capisco le loro spiegazioni. Liceo migliore, dicono, migliori studi poi. È per il tuo bene. Non ci credo.
Non voglio crederci. Ho bisogno di essere infelice e loro mi danno una ragione d’esserlo. Non sono completamente scemo. Obbiettivamente, non ho tutte queste ragioni per lamentarmi. Lo so, me lo ripetono spesso: «Guardati intorno, pensa un po’ anche agli altri, ci sono tanti più infelici di te.»
Che ne sanno loro di me? Sono libero, dentro di me, ma anche solo, perso. Ho male e ho paura.
Paura.
Non ho ragione di avere paura
Ho centomila ragioni di avere paura.
Un accento sbagliato nel dettato.
Un bottone che manca ai pantaloni.
Una macchia d’inchiostro sul tappeto.
Un quaderno strappato.
Un buongiorno dimenticato.
Una parola di troppo.
Un bicchiere rotto.
Basta a distruggere l’equilibrio.
Cammini su un sottile strato di ghiaccio,
scivoloso e fragile.
A ogni passo puoi cadere o sprofondare.
È la vita.
Bisogna rispettare le regole.
Regole che nessuno ti ha insegnato.
A te indovinarle.
Se no, tanto peggio, sei eliminato.
È la vita.
Mia madre ha chiuso la porta dietro di me. Scendo le scale, un piano e sono in strada.
Non mi ricordo mai del momento dell’addio. Non mi entra in testa. Divento assente, inevitabilmente, mi paralizzo per attraversare quei pochi secondi senza troppi danni. Senza piangere, soprattutto. Io piango facilmente, tutte le emozioni mi salgono, liquide, agli occhi e scendono, senza pudore, sulle guance rotonde e ben nutrite. Allora mi blindo dentro. Ci riesco molto bene quando voglio, quando penso in tempo a chiudere ogni via d’uscita.
Ecco, sono partito. Fa freddo, è grigio. Fa sempre freddo quando parto. Cammino fino alla fermata dell’autobus. Sono in anticipo, non so fare altrimenti. Aspetto, le spalle incassate, la valigia a terra. Non è ancora troppo difficile adesso. L’autobus è quasi vuoto la domenica sera. È sufficiente mostrare il biglietto all’autista, percorrere il corridoio senza guardare i passeggeri già seduti, e sedermi. Evitare l’ultima fila, quella in fondo. A volte ci si rifugiano le coppiette o, peggio, una banda di ragazzi. Che ti beccano sempre.
È più difficile dopo, in treno. C’è sempre movimento: a ogni fermata, salgono passeggeri, camminano nel corridoio centrale e ti scrutano, ti valutano. Soprattutto non guardare, concentrarsi, ostili, sul proprio libro. Io sono una cittadella inespugnabile, una roccia dura, fredda, inaccessibile. È strano: il posto accanto a me è l’ultimo a essere occupato. Il viaggiatore che si siede sembra scusarsi, con uno sguardo, un cenno del capo. Io sorrido appena, per rassicurarlo, poi ripiombo nella lettura. Fingo indifferenza, ma la presenza accanto a me mi terrorizza. Quello che ancora mi stupisce, ogni volta, è che l’altro non veda la paura che mi brucia le guance e che mi renderebbe muto se mi rivolgesse la parola.
A Parigi, devo cambiare stazione. L’autobus è pieno zeppo. Non so cosa fare della valigia. Se me la sistemo tra le gambe, l’equilibrio diventa ancora più precario. Se la tengo con la mano, va a sbattere contro le ginocchia dei vicini. Poi, ci sono tutti quei corpi che premono contro il mio. Toccamenti involontari che mi provocano disgusto per il mio corpo. Sono troppo grosso, cicciotto, «di taglia un po’ forte» dice mia madre alle commesse dei negozi d’abbigliamento. Infagottato in un impermeabile troppo stretto, tento in ogni modo di dimenticare tutta questa carne ingombrante che mi impaccia; ogni contatto, ogni sfioramento di un altro corpo mi ricorda la mia pesantezza.
A volte, ci sono sguardi insistenti, di uomini che ti soppesano, cercano di attraversarti. Quel certo modo di fissare un punto proprio accanto a te. Un richiamo, una promessa, una minaccia. Ho un bel dare la schiena, lo sguardo mi brucia la nuca, lascia un sensazione, un po’ dolorosa, un po’ eccitante, che si irradia lungo la colonna vertebrale. Mi raddrizzo, stringo le spalle. Cerco un viso rassicurante, una vecchia signora che stringe la borsa sulle ginocchia, una bambina che succhia il braccio alla sua bambola. Il tempo è interminabile fino alla fermata successiva, quando i corpi si allontanano gli uni dagli altri, nel movimento dei passeggeri che scendono dall’autobus. Mi sposto appena, cerco la protezione di una schiena per sfuggire a uno sguardo. L’autobus riparte, è finita. Sono scampato a un pericolo che non so nominare, e ho solo indovinato. La nuca si decontrae, le spalle si fanno meno rigide. Sollievo. Impressione di essere sporco, anche. E un vago rimpianto. Nausea.
Nuova stazione. Nuovo treno. Per un'altra periferia. Ho freddo. Ho sempre freddo in questo treno. Perché è così tetro? Perché ho l’impressione che ingoi la notte invece di attraversarla? Pochi passeggeri. È già tardi, tutti sono al caldo, nelle loro case. Almeno qui nessuno mi darà fastidio. C’è solo una coppia nello scompartimento, lui sfoglia il supplemento di un quotidiano, L’Equipe, lei conta i punti del suo lavoro a maglia. Per loro non esisto. Posso persino guardarli, senza pericolo. L’uomo, ha la testa un po’ china di lato, tiene il giornale a braccia tese. Le sue labbra borbottano qualcosa. Lo odio. Senza alcuna ragione, brutalmente, mi monta dentro, nella pancia, nel petto, in gola. Lo odio. Non mi ha fatto niente. Non mi disturba, non mi minaccia. Ma lo odio. Lui, e gli altri come lui. Lascio prendere forma dentro di me a qualcosa che non ha nome, un sentimento cattivo, doloroso, che a poco a poco si solidifica, scotta, uno schizzo di lava che gli sputo addosso. Con un solo sguardo. Se in questo istante mi guardasse negli occhi, morirebbe carbonizzato, fulminato. Ma lui continua a leggere il suo giornale. Calcio, serie C, Douai batte Armentières, 3 a 1.
Salvo. Sei salvo. Ti risparmio la vita. Non ti odio più. Non mi interessa. È solo un gioco. Mi sento vuoto. Un gioco idiota. Nemmeno divertente. Ho pietà di te, signore. Di me, no. Un senso di vuoto. Mal di pancia. Freddo. Oltre il finestrino, sfumano le luci, il treno sobbalza sui binari, la donna sferruzza, a labbra strette. È ancora presto.
Distolgo lo sguardo. Guardo l’orologio, 20 e 35. Il treno non deve fare ritardo. Ho dieci minuti a piedi dalla stazione al liceo. Alle 21, chiudono le porte. Nessuna pietà per i ritardatari.
Non me ne frega niente di arrivare in ritardo. Sarebbe meglio, addirittura, che questo treno non arrivasse mai, saltasse la stazione dove devo scendere, sprofondasse nella notte, attraversasse città e campagne, in un viaggio senza fine e senza ritorno.
Mi raggomitolo nel mio angolo, raccolgo il mio corpo che rischia di andare in pezzi, cerco di riscaldarmi. Il treno rallenta, si ferma. È ora. Afferro la valigia, scendo.
Cammino meccanicamente. La forza dell’abitudine. Percorso obbligato: attraversare la piazza, prima via a destra, buissima; attraversare la strada; dopo trecento metri, a sinistra, c’è l’ingresso del convitto. Un buco nero sul cortile, un po’ più in basso della strada. Una scala in pietra. Salire un piano. L’ingresso. Un sorvegliante dietro un tavolo. Mostrare il permesso d’uscita. Il mio nome spuntato dalla lista. Qualche passo a destra, nel corridoio troppo largo, vuoto, buio. I passi si appiccicano al linoleum. Una pozza di luce davanti alla porta, grande, aperta, della sala studio.
È lì che devo precipitarmi, senza pensarci, precipitarmi mascherando la paura che è risorta, di colpo, e mi conficca i suoi artigli nella pancia.
Eccoli, sono lì e ti aspettano.
Gli altri.