Da qualche mese è uscito Amori tossici di Laura Pigozzi. Come nei precedenti suoi saggi (come Troppa famiglia fa male o Adolescenza zero, che su questo blog abbiamo recensito), anche qui Pigozzi tratta di educazione, sentimenti, relazioni, crescita, famiglie, infanzie e adolescenze: tutti temi importanti che, a cominciare da Mio figlio mi adora, fin dall’inizio della propria ricerca la psicoanalista ha analizzato, mettendo in luce sofferenze, abitudini, culture familiari, comportamenti tipici del nostro tempo, che sebbene pervasivi e spesso eclatanti in alcune manifestazioni estreme, tendono a celarsi, risultare ingannevoli, ambigui e non chiaramente identificabili. Come tutti i saggi che lo hanno preceduto, anche Amori tossici ha un raggio ampio di indagine e riflessione e, lungi dall’essere un manuale di auto aiuto sul tema (oggi in voga) delle relazioni tossiche - che non sono solo quelle amorose, ma anche quelle familiari che connotano i rapporti fra genitori e figli - , tocca aspetti solo apparentemente distanti della nostra vita affettiva, sociale, economica, politica, portandone a galla la complessità e le interconnessioni. Ringraziamo Laura Pigozzi per avere risposto alle nostre domande.


Intanto cosa intendi con amore tossico?
Un amore tossico è quando capisci che qualcosa non va, ma c’è un incantesimo che ti impedisce di vedere bene, di andare, di mollare, di salvarti. E ti dici: forse riesco a raddrizzare questo amore, forse qualcosa cambierà. Ma l’assoluto che rende l’amore tossico un gorgo abissale, un maelström degno di Melville, è più forte di ogni buona intenzione. L’amore tossico è la tua Moby Dick: sai che ti ci schianterai, sai che dovresti lasciar perdere, ma non puoi mancare all’appuntamento. Lo vedi come un destino.
Al centro del tuo saggio hai posto il concetto di confine, e la continua necessità di sconfinamento che sembra appartenere al nostro tempo.
Dell’amore tossico non volevo fare solo un inventario, un elenco o, peggio, dare statistiche, secondo lo stile attuale, nomenclatorio e descrittivo, oggi in voga e considerato addirittura scientifico, ma in realtà solo prudente. Non volevo raccontarne semplicemente le varianti, che pure sono presenti sotto forma di casi, di film, di romanzi. Quello che mi interessava maggiormente, era rischiare un’interpretazione, trovare una guida per capire quando un amore è tossico e quando invece è un amore passionale. Non bisogna fare confusione, l’amore-passione può essere tossico, ma non lo è per definizione, non tutti gli amour-passion lo sono. L’amore tossico è quando la passionalità è a senso unico: solo uno dei due è dentro il gorgo, l’altro lo guarda annaspare. L’idea di confine, allora, mi è sembrata una metafora e un significante che potesse fare da buona guida, da chiaro discrimine per capire quando l’amore si perverte. E lo fa, secondo la mia lettura, quando il confine si sfalda e il soggetto è invaso (vale anche quando è la vittima stessa a chiedere di essere occupata dall’altro). Oppure è tossico, nella seconda ipotesi, quando il confine si irrigidisce in un muro espulsivo. In questo, il confine nell’amore è molto simile al destino dei confini nella guerra: muri e sfondamenti. A volte entrambi.
Se noi prendiamo la metafora della membrana cellulare, vediamo che la cellula sana scambia con l’esterno nei due sensi, mentre quando si ammala viene aggredita, a senso unico, da un’altra cellula (cancerosa, ad esempio). Ecco, nell’amore il confine dovrebbe restare poroso, come in una cellula che funziona e che scambia nutrienti con l’esterno.
Mi ha colpito la tua affermazione: “L’amore c’è quando si riesce a tollerare l’impossibile che l’amore è”, concetto che pare andare in controtendenza, oggi.
Tra i tanti film citati nel libro ce n’è uno francese, Une liaison pornographique (1999) in cui il protagonista tronca la relazione nel momento in cui è al suo apice, quando può nascere un coinvolgimento affettivo. Così motiva la decisione: «Finiremmo per detestarci. Non ci rimarrà che il ricordo di questa perfezione. Allora tanto vale lasciarci». In fondo il serial lover, nella ripetitività dei suoi schemi, è un conformista più che un creativo, uno schiavo della sequenza più che uno spirito del libero amore. Fedele alle repliche, di cui la prima performance si perde nella notte dei tempi e forse non c’è mai stata se non nel suo fantasma, non tollera l’imperfezione della vita e chiude una storia prima che diventi umana, cioè imperfetta. Tuttavia, l’amore c’è quando si riesce a tollerare “l’impossibile che l’amore è.” Un’ambivalenza difficile da tollerare: si tratta della tolleranza di un amore non preordinato, non come lo vorrei, che mi sposta dalle certezze, che non si conforma a ciò che ho sempre cercato, che mi sorprende. E che ha dell’impossibile magari rispetto alla mia storia, alle tradizioni famigliari, al già saputo e addirittura al già immaginato. Un amore non assoluto, non totale, non perfetto, che lascia un mistero. Che ci può meravigliare. La dedica del libro forse è una pista. E poi ci sono due esempi illuminanti che aprono il capitolo sull’amore possibile: quello di una coppia di amici e quello di una coppia di musicisti che sono una coppia solo artistica. L’amore è l’incontro tra due mondi diversi, tra due universi profondamente esogamici.
L’amore possibile è il non controllo, mentre oggi, hai ragione, amore e controllo sono spesso indistinguibili: una sovrapposizione che inizia in famiglia e a cui ci si abitua troppo facilmente.
Un altro dei fenomeni di cui tratti ripetutamente in queste pagine è quello della alessitimia. Di cosa si tratta?
Alessitimia è quando mancano le parole per dire ciò che si prova e se non ci sono le parole non si riconosce ciò che si sta vivendo: si è vissuti, più che vivere. A volte, un’analisi è proprio mettere le parole al posto dei buchi di senso. Il termine viene dal greco a, «mancanza», lexis, «parola» e thymos, «emozione»: avere difficoltà a distinguere gli stati emotivi dalle percezioni fisiologiche. Non a caso questo lemma è stato introdotto nel 1976 da John Nemian e Peter Sifneos per definire una costellazione di sintomi riscontrabili in personalità con disturbi psicosomatici, oggi pervasivi, perché ciò che non viene simbolizzato, ciò che non passa per l’elaborazione della parola, ammala fisicamente il soggetto. Nel libro ci sono elaborazioni e ipotesi cliniche intorno a due flagelli contemporanei: la fibromialgia e le dermatiti atipiche, fenomeni in crescita esponenziale. Il sintomo, anche quello fisico, può essere un discorso molto articolato laddove la parola manca.
L’alessitimia fa decadere anche il pensiero perché, come i neurologi e anche i neuroarcheologi hanno visto, aree cerebrali sovrapponibili si accendono quando un soggetto costruisce un oggetto complesso e quando parla. Parlare e pensare attivano le stesse aree anatomo-funzionali.
Anche la diffusa tendenza a etichettare, in inglese labelling, legata alla grande questione del genere, è estremamente interessante, in queste pagine. In che modo si allaccia al tema del libro?
Oggi pensiamo di capire le cose moltiplicando le definizioni, anche nelle patologie. A ogni edizione il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) si amplia. La vocazione enciclopedica non sostituisce la ragione profonda dei fenomeni, non è nella moltiplicazione che si comprendono. Se tanti fenomeni appaiono insieme in un’epoca c’è una ragione. Per il gender, l’acronimo LGBT, Lesbiche Gay Bisessuali e Trans, è diventato LGBTQ&A, comprendendo i Queer (letteralmente strano, inclassificabile) e gli Asessuali (a cui si dedica un paragrafo apposito). Ma anche nel campo degli amori tossici non ci si accontenta di ghosting, gasligher (leggerete nel libro di che si tratta, e il film di riferimento, una storia appassionante che ha a che fare con un Oscar) e serial lover (che metto in relazione strutturale coi più nefasti serial killer). Anche qui ecco il miracolo della moltiplicazione dei nomi: banskying, l’amore che si autodistrugge come l’opera del famoso artista; zombing, coloro che ritornano dopo una sparizione o dopo un periodo in cui si sono presi una pausa; il birdboxing, che viene da un (brutto) film, Birdbox, in cui una madre per salvare sé e i propri bambini si benda per non guardare mostri che portano alla pazzia: l’espressione indica l’essere ciechi ai difetti di una relazione morta; il breadcrumbing ovvero seminare briciole di pane all’altro, farsi seguire, ma non sfamarlo, non concretizzare la relazione che resta ambigua; l’orbiting cioè girare a vuoto intorno a qualcuno in maniera non chiara; per finire con il vecchio evergreen del love bombing, sorta di plusmaterno relazionale, esercitato da persone che ti bombardano d’amore. Una curiosità: questo termine fu coniato negli anni ’Settanta negli Usa per descrivere il meccanismo d’azione con cui i leader di alcune sette religiose adescavano i loro adepti ed esercitavano un controllo sui loro seguaci.
Come dalla moltiplicazione di nomi non si capisce la struttura del fenomeno dell’amore tossico, così la moltiplicazione dei gender non illumina meglio la sua nascita e il suo significato. Sul tema gender ho scritto una cinquantina di pagine in Amori Tossici, pagine che scontenteranno alcuni e che altri troveranno interessanti, anche perché non c’è ancora molta letteratura sul tema, se non altro perché avanzo ipotesi cliniche in un mondo che non vuole più saperne, o quasi, di interpretazioni. Si tratta di un tema in evoluzione, ma al momento considero quel testo quanto di meglio io abbia potuto esprimere teoricamente su questo spinoso, difficile, ostico argomento. Fatti salvi i diritti sociali e sanitari dei trans e l’aspetto politico del gender che oggi ha più forza di quello teorico (la transrivoluzione), mi concentro soprattutto sul significato del desiderio trans nei minori, situazione che getta nell’angoscia le famiglie. Ho pensato che potrebbe essere utile capire come si articola la questione transgender con la questione del confine: il trans è una figura del confine anche nel suo stesso nome che evoca un passaggio da un genere a un altro. Inoltre, voglio ricordare che la psicoanalisi è sempre stata gender fluid, nel senso che non si è mai fatta illusioni che in un essere umano il genere possa coincidere perfettamente con il sesso biologico. Merito della transrivoluzione è quello di avere disintegrato il concetto di identità, ideologico e fumoso, mentre per la psicoanalisi ciò che conta è la più mobile identificazione. La questione trans, soprattutto per i minori, è complicata e fine ed era necessario un esame teorico anche per sfumare un po’ la lotta senza quartiere su cui oggi ci si accapiglia. Ho cercato di argomentare pensando alle persone concrete che ho incontrato con questa richiesta, cioè volgendomi alla clinica che è sempre una bussola anti-idealizzatrice, e, quindi, ho avuto bisogno di molto spazio per sciogliere qualche nodo che oggi attanaglia molte famiglie di minori trans. Perché è dei minori che parlo da sempre e di cui mi interessa maggiormente perché sono quelli più indifesi.
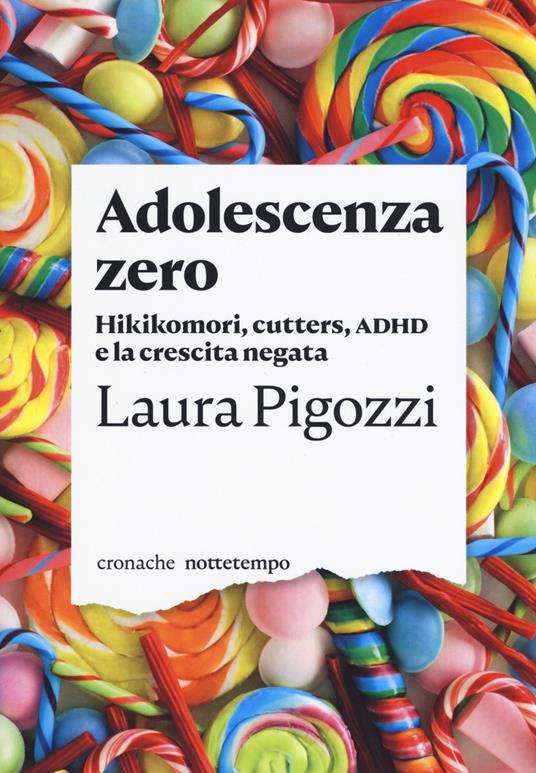

In questo, saggio come hai fatto nei precedenti, affermi che la genitorialità non è una funzione naturale, ma culturale. Per quale ragione è così difficile prendere le distanze da questo stereotipo?
Perché il plusmaterno è coestensivo al capitalismo in cui tutti siamo immersi, non solo come godimento dei beni/bambini, ma anche proprio nel funzionamento mentale. In questo libro aggiungo qualche tassello al concetto di plusmaterno posto per la prima volta in Mio figlio mi adora, che hai avuto il coraggio - sì, il coraggio perché era la prima volta che si osava smontare qualche tabù sul materno - di ospitare qui. Mi chiedo anch’io come mai questa modalità di attaccamento perverso ai figli sia così diffusa e, quel che è peggio, perché sia narrata come buona. Una delle mie risposte è: perché anima il funzionamento stesso del capitalismo, nel senso che plusmaterno e capitalismo esistono nell’eccesso, nel fuori limite. Il capitalismo, dice Todd McGowan, filosofo sociale dell’Università del Vermont, è «la produzione eccessiva di ciò che non è necessario ed è essa stessa necessaria per la sopravvivenza del capitalismo. La sovrapproduzione è la linfa vitale del capitalismo». L’aveva già detto Marx, ma oggi le dinamiche sono cambiate e ritrovare questo pensiero può aiutarci a capire meglio. Il plusmaterno si riproduce attraverso il godimento del bambino (riprodurre sempre il bambino, anche quando di anni può averne una cinquantina e più); il capitalismo si riproduce attraverso il godimento della merce che viene costantemente riprodotta anche se inutile. Vedete cosa capiamo, se lasciamo stare l’apparenza dei fenomeni e pensiamo alla loro struttura di funzionamento? Plusmaterno e capitalismo non hanno davvero a cuore il futuro, bensì il godimento nel presente. Il surplus capitalista minaccia l’esistenza stessa del pianeta, come il surplus di accudimento plusmaterno minaccia l’esistenza stessa del bambino. Se il motto del capitalismo è troppo non è abbastanza, lo è anche quello dell’amore tossico e senza limite della plusmadre.
Cos’è il ‘mito della genitorialità positiva’ e che conseguenze ha nella vita familiare e collettiva?
C’è una favola pseudoscientifica che circola tra i genitori, secondo la quale baciare sulla bocca i bambini, allattarli a oltranza, dormirci insieme, dir loro ti amo, o iperaccudirli, farebbe bene al loro sistema immunitario e li proteggerebbe maggiormente dal rischio di malattie future. Non credo, di sicuro so che non li protegge certo dalla dipendenza che è una malattia, e piuttosto grave.
Obiettivo comune delle generazioni precedenti, spieghi, era crescere, diventare grandi. Perché, oggi, questo non corrisponde più al programma principale della società e dei nuclei familiari?
Perché il cittadino-bambino fa comodo a tutti: ai politici, ai leader e ai genitori. È il bambinone che non cresce, che fa un po’ la vittima (a cui si dice “Poverino, sì hai ragione gli esami sono difficilissimi; sì è così, piccolo mio, è stressante avere una ragazza, e quante pretese ha, quante attenzioni vuole!”). Il cittadino-bambino ha un bisogno costante dell’altro per ogni minima cosa, è colui che non si procura niente da sé, figuriamoci un lavoro. È dipendente e anche un molto ubbidiente: è il sogno di ogni dittatore. Politico o genitoriale che sia.
Sai cosa mi diceva mia nonna? “Su de doss”: è un detto milanese. Lei mi ha cresciuto amandomi profondamente, era anche molto affettuosa, ma per fortuna mi diceva “Su de doss” ogni volta che facevo la lamentina richiedente. So che le sarebbe piaciuto coccolarmi allo sfinimento in quei momenti, ma lei sapeva che questo non mi avrebbe aiutato. Invece che “ascoltarmi”, nel senso che viene promosso oggi persino da qualche collega, facendosi adorare perché esaudiva ogni mia richiesta, mi invitava a non appoggiarmi, a reggermi da me, a non stare addosso a lei, insomma a cavarmela, a procurarmi ciò che volevo, o a inventarmi una strategia per avere ciò che desideravo. Metteva in moto il mio pensiero. E mi insegnava a desiderare. “Su de doss”, adesso che ci penso è un bel titolo: magari lo uso per un prossimo libro, un po’ ironico, dedicato ai giovani.
Una delle cose più interessanti del tuo sguardo sulla dimensione individuale e familiare è il modo in cui le rapporti al piano collettivo, sociale, economico, culturale. Per esempio riporti il pensiero dello psicoanalista Christopher Bollas sulla trasformazione del Sé collettivo, anche relativamente alla necessità di approfondire la capacità introspettiva come antidoto all’individualismo contemporaneo, e anche come estrema difesa della democrazia.
Le nuove malinconie e le nuove psicofobie, in cui si privilegia la vendetta, la rabbia, il diniego, e un senso catastrofico di perdita di sé sono il risultato del dare sempre ragione ai figli, del non pretendere che facciano, come tutti, la loro parte. Dal volerli ascoltare sempre e capire in tutto anche quando dicono sciocchezze regressive per la loro vita. È una conseguenza del non dirgli mai “Su de doss”. Ovviamente parlo di casi in cui non ci sia una patologia conclamata. Secondo Bollas - e ha ragione - noi siamo deprivati dei presupposti umanistici e dei sistemi di credenze della nostra cultura, quelli che offrivano una visione progressista dell’umanità e anche fiduciosa, se così posso dire. È come se l’uomo avesse rinunciato a un progetto collettivo di umanizzazione a favore di soluzioni tossiche: Bollas fa gli esempi dell’elezione di Trump e della Brexit, che hanno visto manifestazioni di esaltazione euforica, da parte dei vincitori, o di depressione abissale da parte degli sconfitti, a cui mai avevamo assistito prima, oscillazioni estreme che sembrano dare poca speranza al senso critico. Scivolamenti emotivi in cui si gioca pericolosamente con l’equilibrio psichico. Sul piano del funzionamento della mente si assiste, secondo Bollas, a un certo orizzontalismo, cioè a un’incapacità di creare connessioni consequenziali tra contenuti, modalità che sarebbe alla base dei fenomeni contemporanei di dissociazione diffusa. Collego questo a quanto ho detto più sopra sull’alessitimia. Come uscire, dunque, da un tale soggetticidio? Qui Bollas ricorre all’ipotesi dello psicoanalista britannico Wilfred Bion, il quale postula l’esistenza di una componente gruppale della nostra mente. Forse dobbiamo solo lavorare perché si esprima. Altrimenti siamo finiti. Nessuno si salva da solo.
La democrazia, allora, prima ancora che una teoria politica, è una modalità di funzionamento della mente in cui coesistono molti concetti, anche in disaccordo tra loro. Infatti, l’inconscio non conosce contraddizione, non è retto dalla logica classica aristotelica (o A o non A), ma dalle logiche non binarie (sia A che non A): anche nell’inconscio il non binarismo conta! Possiamo dire che il funzionamento dell’inconscio è la base mentale della democrazia? Sì, possiamo dirlo, secondo me. In effetti in democrazia si può ancora sognare, nei due sensi del termine: la vita psichica è attiva e posso trasformare i sogni in progetti (le due cose sono collegate).
Allora cosa consigliare ai giovani? Il primo passo, secondo Bollas, dovrebbe essere riportare l’analisi verso la propria interiorità. Come? Promuovendo pratiche centrate sull’uomo: la psicoanalisi per prima, ma anche la letteratura, la filosofia, la poesia, l’arte. Forse davvero occorre spostare il baricentro dalle attività tecniche come la tecnologia, l’informatica, l’economia, se operano senza una visione del mondo che le trascenda e che faccia loro da guida. Consigliare ai giovani, in massa e spesso indipendentemente dalle attitudini e desideri di base, di applicarsi ai soli studi tecnici perché danno lavoro significa preparare una società senza cuore, senza pensiero umanizzante, prostituendo i nostri figli al mercato. Potrebbe non essere una buona strategia. Consigliamo loro invece studi che si occupano del pensiero, indispensabile in ogni stagione storica.
Chi pensa, si salverà. Perché connesso ad altri pensanti.
Quando sono usciti i tuoi primi saggi su questi temi c’è stata una grande attenzione che, personalmente, ho interpretato come un segnale di un desiderio collettivo di cambiamento, per esempio, nelle culture familiari. Oggi, però, ho l’impressione che stia diventando sempre più difficile affrontare questo tipo di discorsi, come se quella che tu chiami claustrofilia stesse diventando la cifra dominante del nostro tempo.
Sì, c’è stata una radicalizzazione del plusmaterno: d’altra parte è più facile godere che pensare. Seguire la pulsione, dimenticando quanto ogni pulsione sia acefala e impastata con la pulsione di morte. Se la si vedesse dietro ogni bacio sulla bocca dato a un minore, dietro ogni tetta che allatta un bambino di oltre due anni (anche uno), dietro ogni condivisione del letto se non per la poppata notturna, avremo più cittadini, più soggetti, gente più eretta sui propri piedi, giovani in cammino verso un progetto e senza la pesante valigia di viveri materni da trascinare.
Il godimento di noi adulti porta i ragazzi nel baratro della dipendenza e della tossicità. Vittime perfette di ogni amore tossico che incontreranno sotto le spoglie di un partner, di un capo, di un’amicizia prepotente. Li fa dei pretendenti perfetti all’essere ascoltati, non nei pensieri, ma nei vuoti lamenti.
Infine, il tuo saggio termina con una difesa appassionata dell’efficacia della psicoanalisi come cura della parola portatrice di senso, in un momento in cui sembrano dominare l’irrazionalità – a un certo punto nel libro parli della credulità ai massimi livelli che contraddistingue la nostra epoca – e un iperscientismo in cui predominano i dati quantitativi e l’umano è marginalizzato.
La negoziazione tra le discipline è cruciale soprattutto da quando è crollato il mito delle scienze cosiddette «dure», quelle cioè in cui predominano i dati quantitativi.
Non esiste solo un amore possibile tra esseri umani, ma anche tra paradigmi scientifici, cioè tra visioni del mondo che danno il ritmo, la musica, il mood al sentire e al pensare collettivo. La PNEI psico-neuro-endocrino-immunologia, unisce discipline che prima erano rigidamente separate, proponendo un’ottica bio-psico-sociale che si dota di più lenti per guardare uno stesso fenomeno, quello del benessere umano. Negli ultimi anni ci sono state alcune rivoluzioni nelle concezioni dell’uomo e della sua salute – l’epigenetica e la PNEI – che manifestano un accordo profondo con le articolazioni del sapere psicoanalitico. La PNEI intrattiene un forte legame con l’epigenetica che è la più recente branca della genetica e che riguarda «ciò che sta al di sopra dell’eredità biologica». Epigenetica e Pnei, che discuto a fondo nel libro, insieme hanno prodotto una rivoluzione nella psicobiologia che sta cambiando radicalmente la tradizionale visione: un individuo può ereditare un gene «malato», ma non è detto che questo si attivi perché molto dipende dalla qualità della sua vita. Inoltre, le mutazioni epigenetiche sono ereditarie: ciò significa che non passo ai miei figli solo i miei geni, ma anche le mutazioni che il mio stile di vita ha impresso loro.
L’epigenetica è forse il link che Freud (che era un neurologo) auspicava arrivasse con le nuove scoperte. Sbarazza il campo dall’ubriacatura dell’alibi da gene che ha reso ebbri tutti gli smaniosi di incolpare la biologia invece che assumersi la responsabilità della propria vita. Con l’epigenetica il romanzo famigliare, connesso a quello dei nostri rapporti con l’ambiente, ritrova una nuova parola e funzione. Una delle sue scoperte fondamentali è che l’ambiente, la famiglia, i genitori, i coniugi, i compagni, lo stile di vita, gli amici (gli amici!), ciò che abbiamo vissuto, tutte queste cose possono modificare l’espressione di alcuni geni, attivando o disattivando il loro piano originario. Cioè la nostra storia modifica l’espressività del gene.
Ciò detto, avete ancora voglia di sostenere a oltranza, di dare stampelle a chi può camminare, di offrire protezioni infinite e ascolti di ogni vagito fuori tempo dei vostri rampolli? O non avete piuttosto voglia di dirgli: Su de doss? Un nuovo rinascimento del sapere, del collettivo e dell’uomo è ciò di cui abbiamo bisogno. Urgentemente.
L'illustrazione d'apertura dell'articolo è di Marion Fayolle da L'uomo a pezzi (Gallucci).
