 «Gli uomini sapevano di non poter essere felici se la loro felicità era collocata e goduta solo nella vita privata.»
«Gli uomini sapevano di non poter essere felici se la loro felicità era collocata e goduta solo nella vita privata.»
«Il compito dei genitori pone le sole vere basi della società, e costituisce l’unica vera risorsa a disposizione del sistema sociale di un paese per rafforzarne lo sviluppo democratico.»
Sono due citazioni che sintetizzano il senso di 290 pagine, ad accogliere il lettore di Troppa famiglia fa male. Come la dipendenza materna crea adulti bambini (e pessimi cittadini), Rizzoli 2020: la prima è tratta da Sulla rivoluzione di Annah Arendt, la seconda da Il contributo della madre alla società, di Donald W. Winnicott.
Il nuovo saggio della psicoanalista Laura Pigozzi, che riprende il filo dei due precedenti e lo perfeziona in quella che si delinea come una trilogia importante per comprendere le dinamiche della famiglia e della società contemporanee in relazione ai processi di crescita delle nuove generazioni, fa una cosa decisamente straordinaria per i tempi che corrono: mostra che l’educazione, la vita familiare, le relazioni affettive, lungi dall’essere qualcosa che pertiene unicamente alla sfera personale, hanno un’importanza collettiva e politica dirompente. Ovvero, in un’epoca di costante privatizzazione di ogni ambito della vita umana, non solo economico, ma anche culturale, sociale, educativo, queste pagine affermano chiaro e forte che la consapevolezza delle conseguenze che i nostri comportamenti hanno sulla società è, oggi, una componente indispensabile per il futuro delle nostre democrazie, della vitalità delle nuove generazioni e della salute del nostro pianeta.
In Mio figlio mi adora. Figli in ostaggio e genitori modello, uscito da Nottetempo nel 2016, Pigozzi inaugura il discorso attraverso una attenta analisi dello stato delle cose nelle famiglie italiane (e non), mettendo a fuoco la sotterranea pervasività di fenomeni come la claustrofilia e il plusmaterno nelle relazioni parentali. Un saggio scomodo, molto dibattuto che ha avuto il grande merito di mostrare come comportamenti adulti contrabbandati per affettività e cure amorevoli siano il risultato di culture familiari e adulte sempre più invadenti, controllanti ed egoiche.

In Adolescenza zero. Hikikomori, cutters, ADHD e la crescita negata (Nottetempo, 2019), Pigozzi concentra lo sguardo sull’adolescenza, mettendo in luce come la presa di distanza e l’affermazione dell’autonomia da parte degli adolescenti sia diventata faticosa e difficile in famiglie e in ambiti educativi sempre più chiusi e soffocanti, in cui la dimensione emotiva sembra avere destituito di ogni importanza la sfera razionale, fondamentale componente per la definizione di ruoli, responsabilità, libertà, e per l’acquisizione di una lingua articolata e personale con cui esprimersi e smarcarsi da vincoli biologici, assurti a legami sacri, in un’ottica quasi di clan.
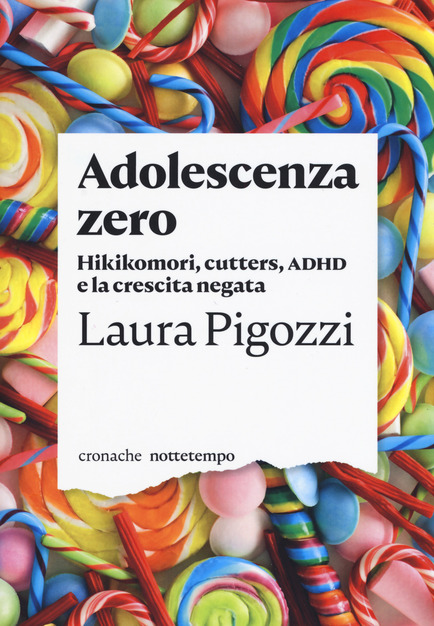
Troppa famiglia fa male è, forse, il più riuscito dei tre saggi, poiché in esso l’indagine assume pienamente e dichiaratamente il carattere politico e sociale che gli è stato proprio fin dall’inizio, esprimendone la piena portata. Il saggio si propone come una denuncia documentata e appassionata di un aspetto del nostro tempo che va ben oltre l’ambito strettamente psicoanalitico, propriamente terapeutico, e invece concerne l’intero ambito delle relazioni fra vecchie e nuove generazioni. L’educazione, le relazioni familiari e affettive che improntano di sé i modelli relazionali acquisiti da bambini e ragazzi, ben lungi da riguardare unicamente le vite private, hanno conseguenze dirette sul piano politico, culturale, economico. Il disconoscimento degli ambiti del collettivo, come la scuola e altre agenzie educanti, da parte delle famiglie, hanno ripercussioni decisive sulla creazione di cittadini in grado di decidere e scegliere liberamente e quindi conseguenze catastrofiche sul futuro e la salute della polis, in cui affondano le nostre radici culturali. Se la famiglia non è in grado di avviare i ragazzi all’autonomia, se funziona in base a dinamiche manipolatorie e istruisce alla dipendenza, al conformismo e si pone come ambito in grado di soddisfare ed esaurire ogni necessità e desiderio dei propri membri, se i nuclei familiari vivono con ostilità ogni contatto con la sfera collettiva e ne disconoscono l’importanza vitale, le competenze fondamentali, l’autorevolezza nella cura e nell’educazione, rifiutando la dialettica fra individuo e collettività che è il fondamento stesso della democrazia, gli individui che escono dal loro seno sono adulti bambini, cittadini inetti e passivi, incapaci di scelta e d sviluppo autonomi, che rifiutano responsabilità e ruoli, inadeguati alla rivendicazione di diritti e all'assolvere doveri.
Vi proponiamo in lettura un brano del saggio. Si tratta del primo paragrafo, dal titolo Il lato endogamico, dal capitolo 5, Il lato politico della cura materna. Ringraziamo Laura Pigozzi e la casa editrice Rizzoli per averci permesso la sua pubblicazione. Trovate il libro qui.
L’ebrea ortodossa americana Deborah Feldman si allontana dalla sua congregazione chassidica e fugge in Europa per seguire il sogno di diventare musicista. Nella sua comunità le donne non suonano né possono cantare: la loro voce esprimerebbe un godimento indicibile e peccaminoso. C’è una correlazione inconscia tra la voce e quel godimento Altro, nominato da Lacan, che in una donna si confonde col godimento, concentrico e diffusivo, che pervade il corpo.
In una scena cruciale della fortunata miniserie Unorthodox, ispirata alla biografia della Feldman, la protagonista fa un’audizione per entrare in una prestigiosa scuola di musica, unica chance che le si presenta per poter restare a Berlino. Quando gli esaminatori le chiedono di esibirsi in un secondo brano non preparato per l’occasione, lei si abbandona a un canto tradizionale che non aveva mai potuto cantare tra la sua gente. Il suono la percorre, lei sembra donarsi a lui: alla voce affida la sua stessa liberazione; la voce le rende possibile una nuova vita. Aprendo gli occhi, dopo l’acuto finale che pare averla trascesa, è la prima a essere sorpresa da quel suono potente, quasi un dolore trasfigurato emesso dal suo corpo minuto. La voce l’ha riparata dal danno endogamico che le comunità chiuse riservano ai loro confratelli, uomini e donne che siano: e infatti anche suo marito è smarrito tra l’osservanza ai precetti e i consigli non richiesti della madre che invade la loro vita intima.
L’endogamia è il male che Tara Westover ci racconta nel suo libro, il male da cui ha potuto liberarsi allontanandosi dalla famiglia. Il guasto endogamico, iniziato dal padre manipolatore e dalla madre sua complice, a un certo punto s’incarna con concretezza in un fratello violento. In teoria la sua avrebbe dovuto essere una famiglia sostenuta dal Bene, da Dio, non destinata già in partenza a essere guasta: una famiglia religiosa, retta da un padre fervente, quasi un illuminato. Un padre che però espone i suoi figli a pericoli fisici, portandoli con sé fin da bambini a lavorare in discarica, un padre che non vede le vessazioni di uno dei suoi figli sulle sorelle. È così che la testa di Tara finisce spesso nel wc, mentre il fratello le torce i polsi fino quasi a spezzarli, e intanto la chiama «puttana». La madre gira la testa dall’altra parte secondo la formula del plusmaterno nella sua variante abbandonica: fingendo di non sapere ciò che accade a una figlia sotto il suo tetto, veicola un’idea perversa della fedeltà alla famiglia, mentre le fa intendere che non c’è vita alternativa all’asfittico mondo familiare. Quando Tara ha il coraggio di denunciare il fratello, la famiglia le chiede di ritrattare e, dato che lei non lo fa, la taglia fuori dandole della bugiarda. La respinge come un corpo estraneo, dimostrando che le famiglie manipolatrici si basano su un patto omertoso. Per mesi Tara perde il possesso della propria mente: «Cosa deve fare una persona quando i suoi doveri verso la famiglia si scontrano con altri doveri – verso gli amici, la società, verso se stessi?». Ogni famiglia plusmaterna è endogamica. Dei sette fratelli di Tara, si salvano solo i tre che abbandonano il nucleo familiare per studiare altrove: la scuola è salvezza perché è lì che per la prima volta s’incontra l’esogamico.
Al di là del modo particolare in cui il male claustrofilico è declinato in ciascuno dei membri, L’educazione è un libro che, raccontando di una famiglia estrema, offre un distillato preciso delle componenti fondamentaliste della famiglia endogamica più comune. Se ne riconosciamo il danno quando è violento ed evidente, come nelle storie di Deborah e Tara, meno facile è rilevarlo nella vita quotidiana, soprattutto quando prende le forme più comuni della cura familiare.
Un’altra storia estrema illumina qualcosa della cosiddetta normalità. Si tratta del caso, fuori dal comune, in cui una bambina di quattro anni, sana, non ha potuto fare il passaggio dalla lingua privata delle lallazioni con la madre verso il linguaggio condiviso, articolato della polis, quello che segna il momento in cui un bambino può farsi intendere da tutti e non solo dalla famiglia. Sua madre – che chiameremo Gaia, come la Terra – è una signora di grande sensibilità, sinceramente desiderosa di aiutare la figlia, la quale, pur avendo avuto uno sviluppo nella norma, era priva di linguaggio e comunicava a suon di balbettii con tutti, trasformando il mondo in una grande culla. Le cose che dirò qui sono poche e parziali, ma possono essere utilissime a tutte le mamme che dovessero rispecchiarsi nel desiderio inconscio che la stessa Gaia ha saputo riconoscere in sé. Qualche dato preliminare: la bambina dormiva con la madre in un letto matrimoniale preparato nella camera della piccola ed è stata svezzata solo a quindici mesi, dopo l’incontro con uno psicologo infantile che ha convinto la madre a staccarsi dalla figlia. Gaia diviene presto molto consapevole della sua posizione, riconoscendo di aver temuto più di tutto la crescita della bambina, allarmata da quella che sapeva essere l’opposizione classica che le ragazzine manifestano verso la madre in una certa fase dello sviluppo. Il desiderio di essere amata per sempre e non contestata è un tratto diffuso nella condizione materna. Per evitare l’angoscia, in gravidanza, Gaia si era convinta di avere dentro di sé un maschio e si rivolgeva alla sua pancia parlando al maschile. A causa della sua formazione e del suo lavoro – è bene sottolineare ancora una volta che si tratta di una donna capace, intelligente, preparata e integrata –, Gaia ha studiato molto bene l’infanzia fino ai dodici mesi. È lei stessa a scoprire, già al nostro secondo incontro, che «linguisticamente la bambina si è arrestata ai dodici mesi perché io ho studiato i bambini fino ai dodici mesi». Sulla bocca della piccola il tempo si è fermato esattamente al momento in cui la mamma pensava di poterla capire. Veramente notevole la consapevolezza che in poco tempo raggiunge Gaia e che testimonia del suo desiderio profondo di aiutare la bambina. Nella stessa seduta, aggiunge: «Devo farle capire che la mamma la ama lo stesso anche se non è più una neonata». Non entro in altri dettagli di questo caso estremamente interessante, sia per discrezione, sia perché mi interessa piuttosto segnalare un tratto che può essere comune a molti ritardi evolutivi nei bambini senza patologie mediche, e cioè la difficoltà di far passare da uno stadio all’altro l’organo più investito pulsionalmente nei piccoli: la bocca, punto d’unione erotica con la madre. Parlare il linguaggio della polis è poter fare il lutto dell’uso della bocca come pura suzione per mettere l’orifizio orale al servizio di un’articolazione significante condivisibile. La bocca come organo di godimento lallatorio si ritroverà poi sublimata nel canto, nell’inflessione della lingua o nel modo di parlare di ciascuno. La bimba di Gaia mangiava molto, succhiava ancora il ciuccio piccolo dei neonati, mordeva quando era scontenta e nei video mostrava il piacere che traeva nel cantare un linguaggio che non riusciva ancora a parlare. La madre capiva ogni cosa e quindi la piccola non aveva nessuna necessità di conquistare le parole. Ma senza una lingua, niente mondo. Alla terza seduta, però, Gaia racconta: «Per la prima volta mia figlia ha detto qualcosa che non ho capito, penso sia un bene».
La polis offre quegli incontri imprevedibili che il nido claustrofilico teme. La città, la funzione del padre, l’orizzonte collettivo, sono l’esogamico. Il corpo della madre, simbolo della famiglia chiusa, uterina, che non lascia andare, rappresenta per tutti l’endogamico abissale. È nella polis, per definizione esogamica, che il sessuale può circolare come Eros. Se la libido circola esclusivamente all’interno, senza passaggi al di fuori del cerchio ermetico, non può che guastarsi. Il fratello di Tara vira in violenza il desiderio sessuale, impossibile da soddisfare, per la sorella: le aggressioni, infatti, iniziano durante lo sviluppo della ragazza. La suocera di Deborah, falsamente riparata dal “nobile” scopo di agevolare la procreazione della coppia, si permette incursioni, di carattere francamente incestuale, sul funzionamento sessuale del figlio e di sua moglie. Freud scrive che «l’essenza della formazione collettiva consiste in legami libidici di tipo nuovo». L’opposizione claustrofilica al legame libidico di tipo nuovo si coglie nella sofferenza della madre, anche di quella più avveduta, quando il bambino mostra un grande attaccamento alla maestra.
La passione della madre dei nostri giorni può tendere a inglobare, a produrre individui disabbonati al legame sociale, spaventati e solitari, candidati a diventare adulti che non si autorizzeranno ad amare chi arriva da fuori, chi desidera mantenere la propria differenza. Quando la casa- rifugio assume valore assoluto, si crea un legame dannoso che raramente si scinde col matrimonio: le separazioni a causa della dipendenza dei figli sposati dalla propria madre rappresentano il 30 per cento delle sentenze. Lo dichiara il presidente dell’Associazione matrimonialisti italiani, Gian Ettore Gassani, che aggiunge: «La Cassazione ha sancito che è addebitabile la separazione giudiziale al coniuge che ha tollerato o favorito l’ingerenza del proprio genitore in danno del ménage familiare e/o dell’altro coniuge. Le ingerenze dei suoceri sono equiparate alle infedeltà coniugali in termini di gravità». I più colpiti da questa pratica sono i maschi: «Prevale statisticamente il dato che le suocere più terribili siano le madri dei mariti, spesso in competizione con le mogli». Il plusmaterno si offre ai figli come esperienza in cui essi non mancheranno di nulla, ma in cui, in realtà, perderanno tutto. Al contrario, la cura materna, quella che mette al mondo, si allea alla funzione paterna solo sposando l’esogamia.
Abbiamo sottolineato che il plusmaterno non è affatto la situazione eccezionale prodotta dalla madre problematica, ma sta diventando la normalità della passione materna attuale, che si diffonde come un contagio. Con un candore disarmante la madre di un ragazzo di ventun anni – un ragazzo che avrebbe possibilità di riuscita nella vita – mi dice che se suo figlio la chiama di notte perché è inquieto lei si infila nel suo letto e lì passa la notte. Il genitore del bambino che non si sa trasformare in genitore dell’adolescente faticherà moltissimo e soffrirà enormemente nel fare quel necessario passo indietro quando il figlio sarà adulto. Altre epoche non hanno conosciuto questo tipo di dipendenza, mai esistita prima, se non nelle situazioni di debilità dei figli. Il discorso sociale attuale giustamente sostiene il ragazzo handicappato e gli comunica in tutti i modi: «Ce la farai». Paradossalmente un figlio senza handicap, con una piccola difficoltà momentanea, viene subito puntellato, per esempio con la richiesta di una didattica di supporto speciale. È come se gli dicessimo: «Non ce la puoi fare da solo», un ritornello che con le parole e con i gesti viene ripetuto ai ragazzi in continuazione.
Questa pedagogia della stampella, propaggine del plusmaterno, che appartiene solo alla nostra epoca, è diventata un fenomeno trasversale. Non la si dismette neanche nelle situazioni sociali in cui è del tutto fuori luogo. Un giorno, a scuola, durante una lezione, alcuni cellulari vibrano, forse per inviare messaggi e cuoricini ai compagni, la nuova forma assunta dai bigliettini lanciati da un banco all’altro. L’insegnante li ritira tutti e su uno schermo rimasto luminoso vede l’immagine di una carta di credito. Chiede informazioni e scopre che una studentessa si stava comprando un paio di scarpe. Durante la lezione. L’immagine della carta era quella della madre che gliel’aveva appena inviata per consentirle l’acquisto.
Questa storia è raccontata in un articolo, poi postato sui social. I commenti si sono concentrati sulla reazione che avrebbe dovuto avere l’insegnante: sulla necessità di ritirare i cellulari all’inizio della lezione e metterli in una scatola erano tutti d’accordo. Nessuna riflessione, invece, circa il comportamento della madre che si suppone dovesse sapere che la figlia in quel momento era a scuola. Il disprezzo per l’aula scolastica è manifesto e anche nei piccoli gesti che sembrano di cura – aiutare la figlia a comprare una cosa desiderata – si cela la svalutazione per la vita dei figli fuori dalle mura domestiche.
